 Luigi Pestalozza ha partecipato giovanissimo alla Resistenza, militando a 16 anni nelle Brigate Giustizia e Libertà. Ha aderito al PCI nel 1956, dopo la destalinizzazione, per poi lavorare presso la Sezione culturale della Direzione del Partito. Esperto di Costituzione e appassionato di musica, ha insegnato storia della musica presso l'Accademia di Belle Arti di Brera ed è stato critico musicale per il settimanale Rinascita. All'attività di storico della musica, alterna quella di giornalista e pubblicista. Come inviato di Rinascita e dell'Unità ha viaggiato lungo l'Africa, seguendo da vicino la Rivoluzione somala. Tra i suoi libri pubblicati: Il processi Muti; Il cittadino; Lezioni di educazione civica; Somalia, cronaca di una rivoluzione. E’ attualmente Vicepresidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (A.N.P.I).
Luigi Pestalozza ha partecipato giovanissimo alla Resistenza, militando a 16 anni nelle Brigate Giustizia e Libertà. Ha aderito al PCI nel 1956, dopo la destalinizzazione, per poi lavorare presso la Sezione culturale della Direzione del Partito. Esperto di Costituzione e appassionato di musica, ha insegnato storia della musica presso l'Accademia di Belle Arti di Brera ed è stato critico musicale per il settimanale Rinascita. All'attività di storico della musica, alterna quella di giornalista e pubblicista. Come inviato di Rinascita e dell'Unità ha viaggiato lungo l'Africa, seguendo da vicino la Rivoluzione somala. Tra i suoi libri pubblicati: Il processi Muti; Il cittadino; Lezioni di educazione civica; Somalia, cronaca di una rivoluzione. E’ attualmente Vicepresidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (A.N.P.I).Nella lunga chiacchierata che ci ha concesso, spazia dall'analisi economica e politica dell'Italia attuale a citazioni legate alla sua vastissima cultura musicale. Ma i racconti che lo vedono più coinvolto sono i ricordi della sua esperienza di partigiano. Ricorda con nostalgia la Compagna Bianchina, “ragazza coraggiosissima”, che trasportava le armi sulla sua bicicletta e della quale, dopo il suo arresto, non si è saputo più niente. E ricorda con simpatia la maitresse del casino, che nascondeva le armi per i partigiani, che per recuperarle dovevano fingersi clienti.
Partiamo dalla tua esperienza di partigiano. Cosa ti ha spinto a entrare nella Resistenza a 16 anni?
Su questo ho scritto addirittura un libro, si chiama Il gioco della guerra. Mi ha spinto la mia vita in famiglia. Appartenevo a una famiglia miliardaria ma di un antifascismo assoluto. Nel ’38 mio padre è stato processato, condannato e siamo stati anche ridotti in povertà. E così all’8 settembre mi sono subito dato da fare per entrare nella Resistenza. Sono entrato esattamente il 20 febbraio 1944, qui a Milano, nel giorno in cui compivo 16 anni. Non vi colpisca la cosa perché eravamo tantissimi così giovani. Occorre pensare che chi aveva 16 anni nel ‘44 aveva dietro di sé quattro anni di guerra, di case bombardate -compresa la nostra-, di morti -il fidanzato di mia sorella maggiore era morto in Albania.
Avendo 16 anni non mi hanno mandato in montagna, ma mi hanno tenuto a Milano. La cosa più straordinaria in proposito è che a Milano eravamo 720 partigiani a fronte di 11000 tra tedeschi e fascisti. Però chi dominava la città eravamo noi, e loro non riuscivano mai a sapere dove noi facessimo un disarmo, o un comizio davanti a una fabbrica all’ora del pasto. Sperimentavamo la solidarietà del popolo milanese, culminata a marzo, con lo sciopero generale di tre giorni. Scioperavano anche i mezzi di trasporto e noi pattugliavamo la città. Per quanto riguarda la mia brigata, Giustizia e Libertà, ci era stata affidata la vigilanza di corso XXII Marzo. Alla mattina i tram non andavano, e tenete conto che scioperare per i tramvieri non era poco perché dovevano starsene a casa, quindi ciascuno si fidava, sapeva che anche il compagno sarebbe stato a casa. Però verso le undici della mattina i tram cominciavano ad andare guidati dai fascisti, e noi gioivamo perché sui tram non saliva nessuno. Gridavano: “Salite, salite, tutto funziona!” e la gente continuava a camminare tranquilla, ignorandoli.
Come vicepresidente dell'A.N.P.I, cosa pensi si debba fare per evitare che l'antifascismo sia percepito unicamente in un' accezione commemor
 ativa?
ativa?È una delle cose che io cerco di fare inutilmente. Qui devo fare una critica in generale all’A.N.P.I, e non sono il solo. Ci battiamo perché l’A.N.P.I diventi trainante nel porre la questione dell’applicazione della Costituzione repubblicana ma nell’associazione prevale un’impostazione celebrativa. All’ultimo congresso abbiamo modificato lo statuto aprendo i ruoli dirigenti anche agli iscritti più giovani senza bisogno che per accedervi si abbia partecipato alla Resistenza. Ma non c’è niente da fare, l’A.N.P.I rimane l’organizzazione della memoria, e non del progetto.
Ora vorremmo sfruttare anche la tua esperienza di musicologo...
La mia esperienza di musicologo parte dal fatto che io non sia un musicologo, ma uno storico della musica. Il termine musicologo si porta dentro il positivismo ottocentesco, e cioè una concezione puramente oggettuale della musica, e non della musica come parte della storia. Musicologo è un termine selettivo, inserito in una concezione specialistica dei rapporti, per cui io so tutto della musica ma mi occupo solo della musica. Questa visione culmina nell’attenzione privilegiata alla cosiddetta “Grande Musica” e nella proposizione della categoria odiosa e che io ripudio del Genio, che è sempre di copertura al potere. Alla base di queste concezioni c’è sempre l’idea come di un’infusione divina che scinde l’unità tra ciò che si è e ciò che si fa e si dice.
Musica quindi come parte irrinunciabile della cultura e della storia, ma ti chiediamo allora, che fine ha fatto il dibattito intellettuale-culturale? Negli anni '60-'70 era molto fervido, dal Formalismo russo al Gruppo 63, alle infinite avanguardie critico-artistiche. Da un po' di tempo invece sembra spento. E' davvero così? O il dibattito esiste ma è sommerso o elitario?
In realtà è scomparso perché dalla fine degli anni ‘70, non soltanto in Italia, ma nel mondo, avviene l’affermazione del capitalismo finanziario su quello produttivo. Le contraddizioni mutano e in questo contesto irrompe un nuovo modello di cultura, che ha in Craxi il suo punto d’inizio nel nostro paese ed è oggi dominante. Io ho conosciuto Craxi anche personalmente e ho avuto a che fare con la politica culturale del PSI quando ero dirigente del settore musica del dipartimento cultura del PCI. Per esempio fui contattato da un dirigente craxiano che mi offrì qualsiasi cifra in cambio del mio impegno per garantire l’appoggio del nostro partito a un loro disegno di legge in materia musicale, per il quale eravamo e siamo rimasti contrari. In sostanza questo nuovo modo di concepire i rapporti in campo sociale, come in campo culturale, si caratterizza per la sua concezione di una funzionalità diretta all’interesse individuale o di gruppo privilegiato ricercata in modo spregiudicato, che finisce per vanificare la libertà del dibattito e negare la ricerca libera dagli interessi materiali dominanti. In questo clima avanza una cultura della neutralizzazione delle idee. Desidero citare un convegno della Confindustra del ‘95 sul tema cultura e scuola il cui documento conclusivo sostiene che, nell’ottica dell’interconnessione tra sistema economico, cultura e formazione, il sistema scolastico debba essere interamente riconcepito e indirizzato alla formazione di “menti d’opera emancipate dal sapere critico”. Questo è alla base di quanto sta avvenendo anche qui nell’università, dove sta prevalendo l’educazione al saper fare su quella al pensare. Questo mi ricorda la politica scolastica del fascismo, che ho sperimentato direttamente, avendo frequentato le scuole del regime fino al ginnasio. Ricordo ancora le rabbiose reazioni repressive suscitate dai miei dubbi di bambino, come quando chiesi perchè, con tutti i mari che esistono, i nostri temi vertevano solo sul Mare Nostrum (allora c’era la smania mussoliniana del Mediterraneo). L’insegnante chiamò addirittura i miei genitori a colloquio col direttore didattico per sapere chi mi avesse insegnato a dire certe cose…Effettivamente, appartenendo io a una famiglia di borghesia democratica, non liberale, ero abituato a pensare e comportarmi diversamente dai miei compagni. E io mi ricordo ancora il dito puntato verso di me della mia maestra che mi redarguiva davanti a tutti, dicendomi “tu sei qua per imparare non per pensare!”. Mezzo secolo dopo abbiamo la Confindustria che dice esattamente la stessa cosa. In questo clima si è disfatto tutto il fermento culturale culminato negli anni ‘60 e ’70.
 Nella tua biografia, anche politica, spicca molto la volontà di mantenere una forte indipendenza di idee. Qual è, secondo te, il ruolo della cultura nel mantenere un’autonomia di pensiero?
Nella tua biografia, anche politica, spicca molto la volontà di mantenere una forte indipendenza di idee. Qual è, secondo te, il ruolo della cultura nel mantenere un’autonomia di pensiero?Occorre a mio avviso riflettere a partire dall’autonomia della cultura, che significa anzitutto autonomia del sapere, venuta meno con il processo di privatizzazione iniziato all’epoca di Craxi e giunto oggi a maturazione. Perché si infierisce in maniera così diretta e implacabile sulla cultura, tagliando i fondi, riducendo l’intervento pubblico a intervento di supporto all’appropriazione privata delle attività culturali, nella totale assenza di un progetto? Perché la cultura, se autonoma, ti educa all’autonomia del pensare. Come ci ha insegnato Marx, ma prima di lui il vero Gesù Cristo, quello non falsato dal Concilio di Nicea, occorre mettere al centro l’Uomo, facendone il perno dell’azione e della trasformazione. È evidente come non si possa riuscire in questo in assenza di autonomia della cultura. Non a caso, le classi dominanti hanno sempre mirato a questo: negare autonomia alla cultura attraverso una politica dell’accesso al sapere come accesso alla formazione tecnica, non umanistica e quindi non in grado di cogliere e analizzare le contraddizioni che dividono gli uomini.
Al termine dell'incontro Luigi Pestalozza, riflettendo sulla fortuna-sfortuna generazionale e paragonando la ricchezza di stimoli e di idee della sua adolescenza al panorama sociale attuale, ci lascia con un’affermazione comprensiva e solidale: “Io ho avuto una vita difficile ma bellissima. Immagino che vita difficile dovete avere voi, circondata dal vuoto”.
Laura Carli e Giuditta Grechi
fotografie di Alessandro Massone




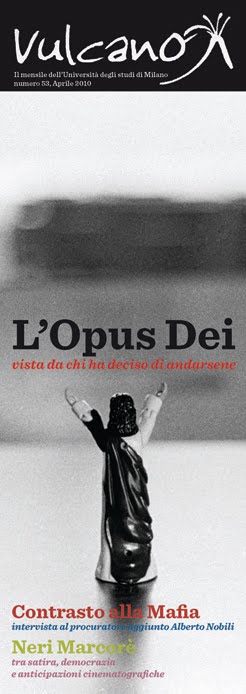















Complimenti! L'intervista è venuta davvero bene! Sono sicuro che anche Pestalozza sarà contentissimo...
RispondiEliminaAlessio
é stato un incontro davvero interessante!
RispondiEliminaGrazie Ale, sei stato disponibilissimo!
giudi
Veramente una bella intervista....
RispondiEliminacomplimenti a tutti, ad Alessio, alle intervistatrici, e a Pestalozza in particolare.
Bella intervista,
RispondiEliminaRocco