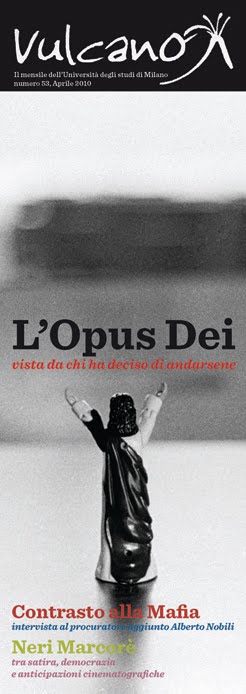INTERVISTA A MARINA NEMAT
Marina Nemat, scrittrice iraniana detenuta ai tempi della rivoluzione komeinista, ha ricevuto il Premio “Human Dignity” dal Parlamento Europeo.
Iraniana cristiana ortodossa, fu arrestata dai guardiani della rivoluzione quando aveva solo 16 anni. Era il 1982. Erano i tempi della rivoluzione islamica dell’Ayatollah Khomeini. Marina non era un’attivista politica. L’unica sua colpa fu quella di aver alzato la mano durante una lezione di matematica per chiedere all’insegnante di non fare propaganda politica. Marina fu torturata, condannata a morte e rinchiusa nella prigione di Evin, a sud di Teheran, nota per il suo braccio della morte destinato ai prigionieri politici condannati alla pena capitale. Una delle guardie che la interrogarono, Ali, si invaghì di lei. La sua sentenza fu ridotta all'ergastolo ma, in cambio, la guardia la costrinse a sposarlo e a convertirsi all'Islam. Così, per due anni rimase in prigione come moglie del suo aguzzino. Quando Ali venne ucciso da altri rivoluzionari suoi rivali nel 1984, fu liberata. Non fece mai parola del matrimonio e di tutto ciò che era accaduto a Evin.Sposò il ragazzo di cui era innamorata prima di entrare in prigione e con lui si trasferì a Toronto, in Canada. Aveva 26 anni.
In tutto questo tempo Marina ha cercato di dimenticare l'Iran, ma oggi, a distanza di vent’anni, le cose non sono affatto cambiate nel suo paese. La morte della madre, nel 2000, e della giornalista iraniana-canadese, Zagara Kazemi, arrestata per aver scattato nel 2003 fotografie della prigione di Evin, hanno segnato una svolta. L’autrice ha trovato la forza di fissare su carta il ricordo, indelebile, dei suoi due anni, due mesi e dodici giorni trascorsi in quella prigione. Per se stessa e per tutti quelli che hanno vissuto lo stesso dramma. “Prigioniera di Teheran” pubblicato da Cairo editore, è la sua storia. Un racconto lucido, commovente e autobiografico di chi è riuscito a ritornare dalla morte alla vita.
L’abbiamo incontrata a Milano, presso il Palazzo Stelline, dove ha ricevuto il Premio “Human Dignity” conferitole dall’On. Mario Mauro, Vice Presidente del Parlamento Europeo, per la sua testimonianza attiva e il suo impegno nella difesa dei diritti umani.
L’abbiamo incontrata a Milano, presso il Palazzo Stelline, dove ha ricevuto il Premio “Human Dignity” conferitole dall’On. Mario Mauro, Vice Presidente del Parlamento Europeo, per la sua testimonianza attiva e il suo impegno nella difesa dei diritti umani.
Un libro difficile. Una scelta difficile quella di raccontare. La sua amica Parisa che, come lei, ha vissuto gli orrori della detenzione, dopo alcune chiacchierate ha deciso che non voleva più ricordare. Perché, invece, lei ha scelto di scrivere?
Non è stata una decisione presa razionalmente ma l’esito naturale di un processo. È arrivato un momento in cui non riuscivo più ad andare avanti, a vivere con questo pesante segreto. Per anni tutti quelli che mi circondavano avevano deciso di ignorare il fatto che io avessi trascorso più di due anni nella prigione di Evin. Tutti avevano cercato di dimenticare, di proseguire con la propria vita ed io, per così dire, sono stata al gioco. Però ad un certo punto ho dovuto affrontare il mio passato, non riuscivo più a dormire, a sorridere. I ricordi si erano fatti insostenibili e soffocanti. Ho dovuto affrontare il fatto che io fossi sopravvissuta mentre molti altri erano morti.
Cosa significava essere cristiana a Teheran durante il regime?
Prima della rivoluzione, nel periodo dello Scià, non era importante la religione che si professava. A scuola eravamo tante ragazzine di credo diverso e convivevamo tranquillamente. Con la rivoluzione islamica le cose sono cambiate. Si è instaurato una legge islamica estrema e a quel punto la religione è diventata un problema. Come cristiana, comunque, sono sempre stata un po’ ai margini della società. Anche nel periodo dello Scià ero leggermente diversa dagli altri e questa differenza l’ho sempre avvertita. Ma non si andava in prigione per il fatto di professare la religione cristiana, purché si rispettasse la legge islamica. Purché non si diventasse, diciamo, politici nel proprio credo. Chiaramente una volta in prigione essere cristiana ha rappresentato un grande svantaggio.
Cosa è cambiato oggi rispetto a vent’anni fa?
Non ci sono molte differenze in realtà. Per un breve periodo, quello della presidenza di Katami, le cose sembravano migliorate, ma erano solo cambiamenti estetici. La donna, ad esempio, poteva indossare un po’ di rossetto, e anche se una ciocca di capelli fuoriusciva dal foulard non era importante. Però erano variazioni molto superficiali. Oggi con la presidenza di Ahmadinejad siamo ritornati a dove eravamo con Khomeini. Sempre più donne subiscono delle pressioni, devono indossare in modo adeguato l’hijab e incontrano grandi difficoltà nella loro vita di ogni giorno. La verità è che fino a quando rimarrà al potere un regime islamico non potranno esserci cambiamenti per gli iraniani. La democrazia è qualcosa di inconciliabile con il sistema della repubblica islamica. Occorre che il sistema cambi perché ci sia democrazia. Fino a quando ci sarà un leader supremo, che ha potere di veto su qualsiasi decisione del Parlamento, non ci potrà essere libertà: questa è la ricetta della dittatura e nient’altro.
In questa storia di odio, dolore, disperazione c’è anche amore, amicizia, resurrezione. Ma ad un certo punto bene e male sembrano confondersi e compenetrarsi. Come ha fatto alla fine di tutto a ritrovare l’equilibrio e scrivere una storia che è anche di speranza?
Penso di dovere questo mio equilibrio al modo in cui sono stata cresciuta. Mia nonna mi ha educata ai valori cristiani, dicendomi sempre di guardare al nemico con il rispetto dovuto ad un altro essere umano, di amare, comunque, il mio prossimo. Questi principi sono stati, per così dire, incisi nel mio animo. Quando sono stata imprigionata, a 16 anni, ero giovanissima e non avevo avuto abbastanza esperienza per poter provare odio. Vivevo alla giornata e, non avendo pregiudizi, se esisteva un minimo di bontà anche nell’essere più vile e più crudele io riuscivo a trovarla. Quello che più mi ha colpito, infatti, è stato scoprire che la famiglia di mio marito, che per me era stato un aguzzino, un torturatore, in realtà era una buona famiglia. È stato così che ho dovuto necessariamente riconciliare il concetto del bene con quello del male. E’ stato lì che ho appreso che il mondo non è o bianco o nero.
Per questo libro ha ricevuto il premio “Human Dignity” del Parlamento Europeo. È un passo avanti perché si cominci a aprire gli occhi sugli orrori della tirannia. Eppure ancora oggi giornalisti in Iran vengono condannati per reati d’opinione. Gli ultimi resoconti ci parlano della morte della fotoreporter iraniano-canadese Zahara Kazemi e della condanna, nel Kurdistan iraniano, alla pena capitale per due giornalisti curdi. Si tratta, quindi, ancora di censura?
Si, certo, si parla di censura politica ma anche di forte omertà. Quando io ero in prigione non c’era alcuna reazione. Praticamente erano migliaia i teenager di 16/17 anni imprigionati in Iran, ma nessuno ne parlava. Addirittura io mi chiedevo se ci fosse qualcuno che sapesse o si preoccupasse di questa situazione. Ma dopo 25 anni di silenzio oggi qualcuno finalmente sta ascoltando. Questo è positivo. Il Parlamento Europeo ha fatto un passo avanti, approvando una risoluzione in cui si riconosce che tutte le minoranze religiose stanno affrontando delle difficoltà: le persone vengono uccise, torturate in nome del proprio credo. Un’atroce tortura fisica, che lascia segni visibili, ma anche e soprattutto una tortura psicologica che logora dentro.
Cosa può fare la comunità internazionale?
Sicuramente non spedire eserciti in Iran o in altri Paesi del Medio Oriente. Sappiamo che la storia si muove lentamente e non si possono risolvere i problemi dell’Iran in un giorno. La cultura mediorientale è estremamente complessa e la Comunità Internazionale deve proseguire il dialogo, deve continuare a parlare della violazione dei diritti umani. Inoltre, i governi occidentali dovrebbero esercitare delle pressioni sul governo dell’Iran perché vengano rilasciati i prigionieri. Oggi c’è anche internet, uno strumento estremamente potente per partecipare a questo tipo di discussioni facendo sentire la propria voce. È un modo per mostrare sensibilità e avviare un dibattito internazionale con la possibilità di scambiare idee e opinioni con cittadini iraniani. E’ necessario ricordare che il 70% della popolazione iraniana ha meno di 30 anni, quindi sussistono speranze effettive di cambiamento. Bisogna aspettare che i cittadini iraniani trovino la loro via verso la democrazia quando ne saranno pronti.
Vivendo in nord America, conoscendo la realtà di questo paese, trovo disturbante il fatto che la gente si concentri di più su quelli che sono i problemi di Britney Spears piuttosto che delle vite perdute nelle guerre in Asia o Africa, o si concentri di più sulle avventure di Paris Hilton, piuttosto che sulle vittime dell’AIDS nel terzo mondo. Dobbiamo renderci conto che la cultura popolare deve ridefinirsi, deve cambiare le proprie priorità perché, come diceva giustamente lei, le atrocità vengono tutt’ora commesse a livello mondiale. Bisogna chiedersi se è normale per un essere umano ignorare. Se le vere necessità del pianeta vengono riconosciute è necessario poi assumersene tutte le responsabilità. E questo, si sa, non è certo facile anzi è molto scomodo.
Silvia Valenti
Sicuramente non spedire eserciti in Iran o in altri Paesi del Medio Oriente. Sappiamo che la storia si muove lentamente e non si possono risolvere i problemi dell’Iran in un giorno. La cultura mediorientale è estremamente complessa e la Comunità Internazionale deve proseguire il dialogo, deve continuare a parlare della violazione dei diritti umani. Inoltre, i governi occidentali dovrebbero esercitare delle pressioni sul governo dell’Iran perché vengano rilasciati i prigionieri. Oggi c’è anche internet, uno strumento estremamente potente per partecipare a questo tipo di discussioni facendo sentire la propria voce. È un modo per mostrare sensibilità e avviare un dibattito internazionale con la possibilità di scambiare idee e opinioni con cittadini iraniani. E’ necessario ricordare che il 70% della popolazione iraniana ha meno di 30 anni, quindi sussistono speranze effettive di cambiamento. Bisogna aspettare che i cittadini iraniani trovino la loro via verso la democrazia quando ne saranno pronti.
Vivendo in nord America, conoscendo la realtà di questo paese, trovo disturbante il fatto che la gente si concentri di più su quelli che sono i problemi di Britney Spears piuttosto che delle vite perdute nelle guerre in Asia o Africa, o si concentri di più sulle avventure di Paris Hilton, piuttosto che sulle vittime dell’AIDS nel terzo mondo. Dobbiamo renderci conto che la cultura popolare deve ridefinirsi, deve cambiare le proprie priorità perché, come diceva giustamente lei, le atrocità vengono tutt’ora commesse a livello mondiale. Bisogna chiedersi se è normale per un essere umano ignorare. Se le vere necessità del pianeta vengono riconosciute è necessario poi assumersene tutte le responsabilità. E questo, si sa, non è certo facile anzi è molto scomodo.
Silvia Valenti