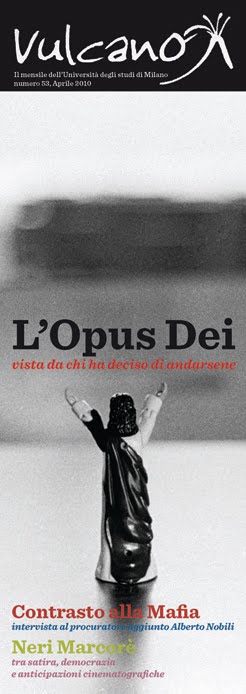Note di italianità a New York
Sulla copertina del New York Times brilla il primo piano di Mark Sanford, afflitto. E’ il governatore della Carolina del Sud ed ha appena ammesso, durante un’apposita conferenza stampa, di aver violato il talamo nuziale con una misteriosa donna argentina. L’incontro mediatico è stato definito ‘valle di lacrime e scuse’, e gli editorialisti americani concordano nel ritenere il repubblicano Sanford definitivamente fuori dalla corsa alla Casa Bianca per il 2012. Semmai, si discute se sia il caso che completi il mandato come governatore dello staterello a nord della Georgia. Parlando di Italia e Stati Uniti di questi tempi, il paragone non può che sorgere spontaneo, fra un Paese in cui un tradimento coniugale basta per stracciare una carriera politica, e un altro in cui ipotesi ben più gravi non scalfiscono il potere costituito. Probabilmente, perché da una parte si discute la credibilità di un uomo politico – tralasciando i dettagli pruriginosi – mentre dall’altra si consuma una stucchevole cronaca di gossip d’alto bordo. Eppure, prima che l’uragano Sanford catalizzasse l’informazione made in Usa, l’Italia ha aperto più volte gli inserti del New York Times: con la notizia delle Nozze di Cana del Veronese, proiettate a Venezia in una performance multimediale di Peter Greenaway, oppure per via degli ultimi fuochi dal pianeta moda, con foto di Milano in primo piano.

La patina che, oltre Atlantico, avvolge lo stivale è evidente. L’idea di un Paese inteso come “occasione mancata” permea tutte le conversazioni, con chiunque, di qualsiasi nazionalità e tendenza politica. Ma a New York, in tempi di globalizzazione, l’Italia da macchietta e folklore è lontana. Nessuno crede più alla bugia dell’ “italianità” di “Little Italy”, quartiere “nazionale” a sud di Manhattan, ridotto ad una Street più o meno breve, colma di tricolori e Laura Pausini in loop nei turisticissimi ristoranti di pizza e pasta. A Nord si distendono le vie del quartiere “Nolita” (North Little Italy: come “Tribeca” è il Triangle Below Canal Street, secondo il logico sistema americano di qualificazione dei neighborhood), e nel cuore di Nolita c’è il Lulu’s Bar, lounge soffuso e a la page, tracimante di trentenni newyorkesi. Lo ha tirato su circa un anno fa Stefania, che dice: “Che domanda è ‘Se mi sento italiana?’ Io sono Italiana! Anche se vivo qui da tanto tempo.” E little Italy? “Una bugia. Si tratta in maggioranza di Italo-Americani. Nel mio locale, frequentato per lo più dalla gente del posto, di autenticamente italiano c’è il calore, la creatività, la voglia di approfondire.” Stefania è arrivata a New York nel 1998 e, secondo un’impressione comune fra gli europei a contatto con la grande mela, la città le era sembrata insignificante: “All’inizio mi sono detta: ‘ma cos’è questo luna park senza neppure un briciolo di storia?’ Poi il suo modo di vivere ti entra nelle vene.” Dopo i primi soldi guadagnati, l’idea di sbarcare nel business della ristorazione è stata immediata: a New York, la città che mastica senza sosta, si registra la più alta densità di pub, ristoranti e delivery al mondo.
Al bancone del Lulu’s un altro esempio di Italia all’estero beve il suo cocktail rosa. E’ Carolina – Carol per Ena, l’amica californiana alle sue spalle che finisce, sorridendo, lo shot di tequila – nata e cresciuta in Abruzzo, ora a New York per lavorare nel settore del design d’interni. La nuova generazione di italiani negli States è, contemporaneamente, più italiana e più integrata di quella precedente. Le donne sembrano capaci di adattarsi meglio degli uomini ai cambiamenti di stile di vita e mentalità. “Faccio un lavoro che mi piace e soprattutto vivo in una città unica – spiega Carolina – Semplicemente, posso fare tutto quello che voglio, quando voglio.” Il suo ufficio è in alto, dentro qualche grattacielo a due passi da Union Square, una delle zone più “europee” e rilassate di Manhattan, dove le torri aggressive lasciano il posto a palazzi originali e meno evidenti, e le vie si rimpiccioliscono, facendo quasi dimenticare la grata che taglia New York in rigorosissime strade orizzontali e verticali.

A Nolita, nel Village, a Chelsea, l’Italia si trova anche nelle code. Per arrivare, ad esempio, nella penthouse di un albergo con piscina in cima – alfine di gustare un tradizionale “aperitivo tricolore” celebrato da un gruppo facebook – la fila in attesa parla in italiano di marketing, e la festa replica gli happy hour brillanti e superficiali della “Milano bene”. Ma anche per ascoltare Jovanotti – impegnato in un lungo tour estivo fra Manhattan e Brooklyn con la sua band internazionale – la coda cianciante di jazz trabocca da un intimo locale d’essai e, con un po’ di fortuna, è possibile assistere al concerto accanto a Fabio Volo, newyorkese d’adozione, che beve serenamente una birra. Nella parte mediana di Manhattan scintillano i grattacieli e le insegne di uno dei simboli della città, Times Square. Il nome della “piazza” (il cui concetto, in realtà, varia molto fra vecchia Europa e Nuovo Mondo) deriva dal giornale che l’ha resa celebre, il New York Times. La nuova sede del più autorevole quotidiano statunitense svetta ora sull’ottava strada, a due passi dalla piazza, e la firma del suo progetto trasparente e sostenibile è di Renzo Piano, interamente italiana.
“Ma bisogna essere realisti – avverte Antonio Carlucci, corrispondente da New York per L’Espresso – politicamente il nostro Paese non conta nulla, e anche per quel che riguarda moda, stile e arte, i media americani concedono molto meno spazio all’Italia rispetto al passato. Chi oggi, da Italiano, riesce ad emergere a New York nel mondo del business o della creatività lo fa con le proprie forze, senza alcun sostegno politico o della comunità d’origine, il cui senso è molto diluito. Del resto, se la prima immigrazione era determinata dalla fame, ora le cose sono molto cambiate…”. Ora, essere italiani a New York equivale più a meno ad essere italiani dovunque nel mondo.
Tuttavia, le cifre di una storia di immigrazione non si cancellano, e i trascorsi di un popolo che ha lasciato il segno nel dna multiculturale degli stati uniti sono ancora evidenti. Washington Square – luogo di ristoro nel centro di Manhattan – è dedicata al leggendario primo presidente degli Stati Uniti. Eppure, davanti la grande fontana centrale, campeggia una fiera statua di “Giuseppe Garibaldi eroe italiano”, mentre nella vasca illuminata di notte, gli zampillii vengono interrotti dalle turiste che, immergendosi in acqua, richiamano vagamente una scena felliniana. Insomma, senza sforzarsi troppo, ci si può sentire a casa anche a New York. E’ questo il segreto della città delle città.
Gregorio Romeo
Fotografie: Federica Storaci












 La patina che, oltre Atlantico, avvolge lo stivale è evidente. L’idea di un Paese inteso come “occasione mancata” permea tutte le conversazioni, con chiunque, di qualsiasi nazionalità e tendenza politica. Ma a New York, in tempi di globalizzazione, l’Italia da macchietta e folklore è lontana. Nessuno crede più alla bugia dell’ “italianità” di “Little Italy”, quartiere “nazionale” a sud di Manhattan, ridotto ad una Street più o meno breve, colma di tricolori e Laura Pausini in loop nei turisticissimi ristoranti di pizza e pasta. A Nord si distendono le vie del quartiere “Nolita” (North Little Italy: come “Tribeca” è il Triangle Below Canal Street, secondo il logico sistema americano di qualificazione dei neighborhood), e nel cuore di Nolita c’è il Lulu’s Bar, lounge soffuso e a la page, tracimante di trentenni newyorkesi. Lo ha tirato su circa un anno fa Stefania, che dice: “Che domanda è ‘Se mi sento italiana?’ Io sono Italiana! Anche se vivo qui da tanto tempo.” E little Italy? “Una bugia. Si tratta in maggioranza di Italo-Americani. Nel mio locale, frequentato per lo più dalla gente del posto, di autenticamente italiano c’è il calore, la creatività, la voglia di approfondire.” Stefania è arrivata a New York nel 1998 e, secondo un’impressione comune fra gli europei a contatto con la grande mela, la città le era sembrata insignificante: “All’inizio mi sono detta: ‘ma cos’è questo luna park senza neppure un briciolo di storia?’ Poi il suo modo di vivere ti entra nelle vene.” Dopo i primi soldi guadagnati, l’idea di sbarcare nel business della ristorazione è stata immediata: a New York, la città che mastica senza sosta, si registra la più alta densità di pub, ristoranti e delivery al mondo.
La patina che, oltre Atlantico, avvolge lo stivale è evidente. L’idea di un Paese inteso come “occasione mancata” permea tutte le conversazioni, con chiunque, di qualsiasi nazionalità e tendenza politica. Ma a New York, in tempi di globalizzazione, l’Italia da macchietta e folklore è lontana. Nessuno crede più alla bugia dell’ “italianità” di “Little Italy”, quartiere “nazionale” a sud di Manhattan, ridotto ad una Street più o meno breve, colma di tricolori e Laura Pausini in loop nei turisticissimi ristoranti di pizza e pasta. A Nord si distendono le vie del quartiere “Nolita” (North Little Italy: come “Tribeca” è il Triangle Below Canal Street, secondo il logico sistema americano di qualificazione dei neighborhood), e nel cuore di Nolita c’è il Lulu’s Bar, lounge soffuso e a la page, tracimante di trentenni newyorkesi. Lo ha tirato su circa un anno fa Stefania, che dice: “Che domanda è ‘Se mi sento italiana?’ Io sono Italiana! Anche se vivo qui da tanto tempo.” E little Italy? “Una bugia. Si tratta in maggioranza di Italo-Americani. Nel mio locale, frequentato per lo più dalla gente del posto, di autenticamente italiano c’è il calore, la creatività, la voglia di approfondire.” Stefania è arrivata a New York nel 1998 e, secondo un’impressione comune fra gli europei a contatto con la grande mela, la città le era sembrata insignificante: “All’inizio mi sono detta: ‘ma cos’è questo luna park senza neppure un briciolo di storia?’ Poi il suo modo di vivere ti entra nelle vene.” Dopo i primi soldi guadagnati, l’idea di sbarcare nel business della ristorazione è stata immediata: a New York, la città che mastica senza sosta, si registra la più alta densità di pub, ristoranti e delivery al mondo.