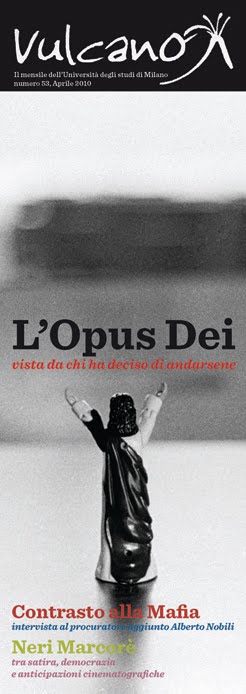Swimming with famous dead shark: così, con un po’ più di una punta d’ironia, The New York Times titola (1-11-2006) un articolo dedicato al “caso” dell’arte che darà filo da torcere a critici, estimatori dell’arte e del gossip: lo “squalo” di Damien Hirst sta marcendo, e allora lui, il pezzo da novanta dei British Young Artists, l’alfiere del contemporaneo, l’asso nella manica della Saatchi Gallery - distributrice planetaria di multimiliardaria paccottiglia contemporanea - che fa? Lo restaura, è chiaro; ovvero, con uno scivolamento concettuale su cui vale la pena soffermarsi, lo sostituisce con un altro squalo; le due bestiole, a dire il vero, sono piuttosto simili – i pesci, si sa, non brillano per espressività – ma questo non ha dissuaso critici bacchettoni e anacronistici nemici del nuovo-che-avanza dal turbare il sonno del povero Hirst con il loro brusio di dissenso. Ma procediamo con ordine: nel 1991 il gallerista C. Saatchi commissiona, per la modica cifra di 50.000£, uno squalo in formaldeide al giovane Hirst, peraltro già arcinoto grazie al suo buongusto anatomico per aver esposto capre, cavoli, mucche e altri animali della fattoria immersi – diremmo imbalsamati, se non fosse termine così passatista – in una soluzione a base di formaldeide. Il gallerista londinese è, si sa, uno che ha fiuto per gli affari, e infatti: alla fine del 2004 l’opera – altresì detta, nostalgicamente, The Physical impossibility of death in the mind of someone living - viene battuta all’asta alla Gagosian Gallery per la cifra record di 6,5 milioni. Il fortunato (!) è S. Cohen, US hedge found manager e munifico collezionista d’arte, che sistema l’opera in casa in attesa della costruzione di un museo dedicato. Ma cosa sarebbe la vita senza un pizzico di brivido: dopo poco lo squalo, in barba all’impossibilità fisica del titolo, irresponsabilmente inizia a mostrare segni di cedimento, si deforma dall’interno e inizia ad emanare un nauseabondo fetore, il tutto galleggiante in soluzione verde speranza. Hirst non era mai stato troppo contento del risultato, di cui, già a suo tempo, diceva “Non incuteva poi così tanto timore. Pareva finto. Sembrava quasi non avesse peso”, il miliardario, invece, non si crucciava troppo - “E’ vero? Non è vero? Sono stato attratto da tutto il fattore di rischio” - e anche la faccenda della putrefazione, tutto sommato... Ma questo per l’artista è davvero troppo: chiama in Australia alcuni fisherman di fiducia, fa pescare un altro squalo, possibilmente con l’aria un po’ più truce, lo carica su un aereo e si rinchiude, armato di maschere, impermeabili gialli, aghi, formalina e imbalsamatori, in un capannone sperduto nel Gloucestershire, per “restaurare” la sua opera a ritmo di rap. “Il lavoro è lungo e complesso - dichiara Mr. Crimmen, responsabile al Museo di Storia Naturale e coordinatore dell’operazione - a causa delle dimensioni del corpo; centinaia di aghi iniettano la formaldeide in profondità, sperando di raggiungere anche i punti più remoti, e la notte l’opera è lasciata a “marinare” in un bagno di formaldeide” – melius abundare quam deficere. Viene da chiedersi quale sia il ruolo di Hirst in tutto questo, ma la risposta vien da sé. L’artista, infatti, assicura che questa volta il successo è garantito: “Quando lo squalo era stato manipolato 15 anni fa avevamo usato una tecnica tutta diversa..”, e, intervistato da S. Morgan, risponde così ai critici: “Mi hanno intervistato a proposito della conservazione delle opere e mi hanno detto che la formaldeide non era la tecnica più indicata. Pensano che io l’abbia usata per tramandare un’opera d’arte alla posterità, mentre in realtà io la uso per comunicare un’idea”. Dunque è così, l’artista ha l’idea, la fa realizzare da altri, prende i soldi e garantisce che “show must go on”. Tra l’altro, alcuni maligni insinuano che l’artista abbia tratto “ispirazione” da un altro squalo, esposto assai prima da E. Saunders nella vetrina del suo negozio in East London, ma non è bene eccedere nella cattiva fede. Comunque, la linea di difesa, come si evince, è davvero molto “concettuale”, eppure non persuade i più, tra cui il conservatore S. Gillespie, che in Keep artists away from their own work sottolinea la capitale differenza tra conservazione, restaurazione e sostituzione, e si interroga sulla legalità dell’intervento di un artista su opere “finite”. In poche parole, la diatriba sembra riprendere da dove Benjamin l’aveva lasciata: digerita la vecchia riproducibilità tecnica – che pure continua a dare i suoi grattacapi al mercato dell’arte – ora approdiamo alla sostituibilità materiale. Autentici miracoli delle idee, occulto potere del concetto, far passare in secondo piano le oltre 20 tonnellate di un innocente pescione, privato della vita e ora anche della dignità di soprammobile per miliardari. La questione è davvero spinosa, a tratti grottesca, se si pensa che il “restauro” – le fonti sull’identità del finanziatore sono oscillanti – avrà un costo stimabile intorno ai 100.000$. Il mondo dell’arte se la ghigna, le parodie si sprecano, ma vale la pena di ricordare che l’effetto advertising per Hirst – in questo più scaltro di una vecchia soubrette – è assicurato. Miracoli del contemporaneo, non si può che amarne l’eleganza sublime.
Swimming with famous dead shark: così, con un po’ più di una punta d’ironia, The New York Times titola (1-11-2006) un articolo dedicato al “caso” dell’arte che darà filo da torcere a critici, estimatori dell’arte e del gossip: lo “squalo” di Damien Hirst sta marcendo, e allora lui, il pezzo da novanta dei British Young Artists, l’alfiere del contemporaneo, l’asso nella manica della Saatchi Gallery - distributrice planetaria di multimiliardaria paccottiglia contemporanea - che fa? Lo restaura, è chiaro; ovvero, con uno scivolamento concettuale su cui vale la pena soffermarsi, lo sostituisce con un altro squalo; le due bestiole, a dire il vero, sono piuttosto simili – i pesci, si sa, non brillano per espressività – ma questo non ha dissuaso critici bacchettoni e anacronistici nemici del nuovo-che-avanza dal turbare il sonno del povero Hirst con il loro brusio di dissenso. Ma procediamo con ordine: nel 1991 il gallerista C. Saatchi commissiona, per la modica cifra di 50.000£, uno squalo in formaldeide al giovane Hirst, peraltro già arcinoto grazie al suo buongusto anatomico per aver esposto capre, cavoli, mucche e altri animali della fattoria immersi – diremmo imbalsamati, se non fosse termine così passatista – in una soluzione a base di formaldeide. Il gallerista londinese è, si sa, uno che ha fiuto per gli affari, e infatti: alla fine del 2004 l’opera – altresì detta, nostalgicamente, The Physical impossibility of death in the mind of someone living - viene battuta all’asta alla Gagosian Gallery per la cifra record di 6,5 milioni. Il fortunato (!) è S. Cohen, US hedge found manager e munifico collezionista d’arte, che sistema l’opera in casa in attesa della costruzione di un museo dedicato. Ma cosa sarebbe la vita senza un pizzico di brivido: dopo poco lo squalo, in barba all’impossibilità fisica del titolo, irresponsabilmente inizia a mostrare segni di cedimento, si deforma dall’interno e inizia ad emanare un nauseabondo fetore, il tutto galleggiante in soluzione verde speranza. Hirst non era mai stato troppo contento del risultato, di cui, già a suo tempo, diceva “Non incuteva poi così tanto timore. Pareva finto. Sembrava quasi non avesse peso”, il miliardario, invece, non si crucciava troppo - “E’ vero? Non è vero? Sono stato attratto da tutto il fattore di rischio” - e anche la faccenda della putrefazione, tutto sommato... Ma questo per l’artista è davvero troppo: chiama in Australia alcuni fisherman di fiducia, fa pescare un altro squalo, possibilmente con l’aria un po’ più truce, lo carica su un aereo e si rinchiude, armato di maschere, impermeabili gialli, aghi, formalina e imbalsamatori, in un capannone sperduto nel Gloucestershire, per “restaurare” la sua opera a ritmo di rap. “Il lavoro è lungo e complesso - dichiara Mr. Crimmen, responsabile al Museo di Storia Naturale e coordinatore dell’operazione - a causa delle dimensioni del corpo; centinaia di aghi iniettano la formaldeide in profondità, sperando di raggiungere anche i punti più remoti, e la notte l’opera è lasciata a “marinare” in un bagno di formaldeide” – melius abundare quam deficere. Viene da chiedersi quale sia il ruolo di Hirst in tutto questo, ma la risposta vien da sé. L’artista, infatti, assicura che questa volta il successo è garantito: “Quando lo squalo era stato manipolato 15 anni fa avevamo usato una tecnica tutta diversa..”, e, intervistato da S. Morgan, risponde così ai critici: “Mi hanno intervistato a proposito della conservazione delle opere e mi hanno detto che la formaldeide non era la tecnica più indicata. Pensano che io l’abbia usata per tramandare un’opera d’arte alla posterità, mentre in realtà io la uso per comunicare un’idea”. Dunque è così, l’artista ha l’idea, la fa realizzare da altri, prende i soldi e garantisce che “show must go on”. Tra l’altro, alcuni maligni insinuano che l’artista abbia tratto “ispirazione” da un altro squalo, esposto assai prima da E. Saunders nella vetrina del suo negozio in East London, ma non è bene eccedere nella cattiva fede. Comunque, la linea di difesa, come si evince, è davvero molto “concettuale”, eppure non persuade i più, tra cui il conservatore S. Gillespie, che in Keep artists away from their own work sottolinea la capitale differenza tra conservazione, restaurazione e sostituzione, e si interroga sulla legalità dell’intervento di un artista su opere “finite”. In poche parole, la diatriba sembra riprendere da dove Benjamin l’aveva lasciata: digerita la vecchia riproducibilità tecnica – che pure continua a dare i suoi grattacapi al mercato dell’arte – ora approdiamo alla sostituibilità materiale. Autentici miracoli delle idee, occulto potere del concetto, far passare in secondo piano le oltre 20 tonnellate di un innocente pescione, privato della vita e ora anche della dignità di soprammobile per miliardari. La questione è davvero spinosa, a tratti grottesca, se si pensa che il “restauro” – le fonti sull’identità del finanziatore sono oscillanti – avrà un costo stimabile intorno ai 100.000$. Il mondo dell’arte se la ghigna, le parodie si sprecano, ma vale la pena di ricordare che l’effetto advertising per Hirst – in questo più scaltro di una vecchia soubrette – è assicurato. Miracoli del contemporaneo, non si può che amarne l’eleganza sublime.
Intanto, però, Hirst tradisce – scivolone di stile – la sua pura vocazione concettuale con una dichiarazione che fa riflettere: per il futuro dell’opera – la seconda, l’unico vero, nuovo originale – l’artista non pare preoccupato, ma dichiara “finchè io sarò vivo, sarò soddisfatto. E’ garantita 200 anni. Soddisfatti o rimborsati”. Il che equivale a dire che l’arte e gli squali saranno anche un concetto, ma il denaro no. E se poi, diciamo tra 100 anni, il danneggiato vorrà avvalersi della garanzia, gli occorrerà un bel po’ di fantasia per indirizzare la sua protesta, dato che Hirst, seppur a fatica, sta ormai entrando nell’età adulta. E già viene da chiedersi; e il primo squalo, quale sarà il suo destino di ripudiato dell’arte? Hirst lo allontanerà dal binomio occhio-cuore, oppure se lo terrà in cantina, prova inconfessabile di un errore di gioventù? Inutile commentare oltre, l’arte contemporanea è così bella, e bisogna, bisogna proprio crederci ciecamente. Anche perché, a pensarci troppo, si rischia di dubitare e di peccare di malizia, il che sarebbe molto demodé…
Viviana Birolli