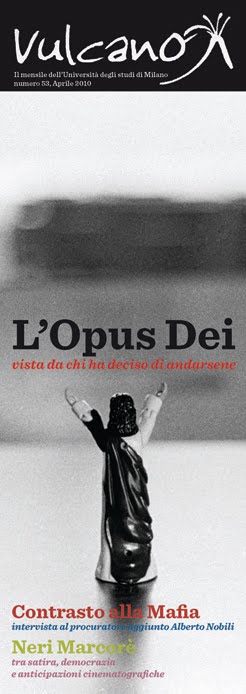Immagino che per tutti noi il Natale sia un albero fatto da mille lucine che cantano Auguri Coca Cola, come fuochi fatui sul grande cimitero del buongusto delle pubblicità natalizie anni ottanta.
Immagino che per tutti noi il Natale sia un albero fatto da mille lucine che cantano Auguri Coca Cola, come fuochi fatui sul grande cimitero del buongusto delle pubblicità natalizie anni ottanta.
Gli spot di natale anni ’80 si concentravano sul valore più saldo della tradizione italiana: la famiglia. E’ del 1982 il panettone Papà Barzetti, marca scomparsa forse per merito anche del proprio marketing: una famiglia prepara l’albero in una casa buia e mentre fuori imperversa una tempesta di neve, la porta si spalanca e compare Babbo Natale; la famiglia esclama: “Papà Natale!”, ma il babbo li corregge con voce oltremondana: “No! Papà Barzetti!”, al che la voce fuoricampo, totalmente monocorde, proclama: “Barzetti, pasticceri di antica tradizione.” Ma non manca anche chi, sempre nel segno della famiglia, osa un po’, sempre con grande rispetto. Non era possibile correre il rischio di essere accusati dall’Osservatore Romano di voler scardinare il vero-grande valore della società italiana, almeno fino a questo Natale. Nell’86 Asti Cinzano interpreta la versione yuppie del Natale in famiglia: un montaggio serrato, ma mica troppo, mostra giovani in doppio petto e belle donne vestite in abito lungo che si ingioiellano, calici di Cinzano ghiacciato sopra vassoi d’argento, bambini bellissimi biondi, anche loro in giacca da sera, una coppia di anziani in piena forma che si abbracciano come due adolescenti. Si stanno preparando per cosa? Un giovane manager afferra un Asti Cinzano e stappa con elegante sicurezza derivata dai propri investimenti: tutti si ritrovano a casa per festeggiare anche quest’anno un ricchissimo Natale. La famiglia è sempre pronta ad indicare la via giusta alle nuove generazioni. E’ così nel 1988 con lo spot del Panettone Battistero: ad un cenone in famiglia partecipa la ragazza del figlio maggiore. Lei è il prototipo della poco di buono: capelli biondi corti e ritti sulla testa, trucco marcato sugli occhi. La tensione è palpabile, tutti, anche la nonna, la guardano male, finalmente arriva il panettone Battistero, ma l’agitazione non cala, anzi le viene chiesto ti compiere il Sacro Rito Del Taglio Del Panettone Battistero, compito che in famiglia da mille generazioni è affidato alla saldissima mano del figlio più piccolo. La poco di buono afferra il coltello, (i più pensano all’insano gesto) fende il panettone dall’alto verso il basso, ma urta il bicchiere dello spumante che, cadendo, macchia la tovaglia di famiglia: i visi si tendono, la situazione sembra essere definitivamente compromessa, ma la ragazza con gesto fermo si bagna le dita con lo spumante rovesciato e se lo passa sul collo: come da nota tradizione. La prova è superata, tutti ridono rilassati. La madre, o la nonna, o entrambe, la abbracciano: anche lei è della famiglia. Lo speaker rassicurante sigilla la redenzione della poco di buono: “Battistero. Un intenso sapore familiare.” E il presepio non lo fa più nessuno.
Fabrizio Aurilia