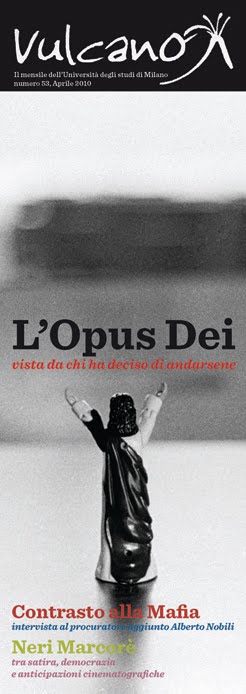Ma in fondo a noi, ma soprattutto a voi, matricole della Beneamata Università Statale, cosa ve ne frega degli anni ’80? Per voi che siete nati nell’88, quando il 47° governo Goria cadeva, (la Repubblica nasce nel 1946, questo è il 61° governo, o il 62° dipende quando uscirà il giornale: 61 maggioranze parlamentari in 51 anni. La Germania dal ’49 ha eletto 9 cancellieri. E non si può dire che il popolo tedesco non abbia avuto i suoi problemini), il decennio in questione non è stato altro che pappine-cacchine-ruttini, ruttini-cacchine-pappine. Sembra la vita di Rutelli, vero?
E allora, cari post-liceali, forse vorreste sentir parlare di banchi di scuola, di cose che conoscete.
Per venire incontro a voi, o classe dirigente del futuro, è pronto un dossier sulla "Terza C". Il 13 gennaio 1987 su Italia1 parte un progetto, "I ragazzi della Terza C", un telefilm che ambiva a raccontare una generazione di studenti ritratti nell’approssimarsi della maturità.
E allora, cari post-liceali, forse vorreste sentir parlare di banchi di scuola, di cose che conoscete.
Per venire incontro a voi, o classe dirigente del futuro, è pronto un dossier sulla "Terza C". Il 13 gennaio 1987 su Italia1 parte un progetto, "I ragazzi della Terza C", un telefilm che ambiva a raccontare una generazione di studenti ritratti nell’approssimarsi della maturità.
Il successo è colossale, non paragonabile ad altre serie americane degli anni Novanta o Duemila.
A parte l’utilizzo di personaggi estremamente stereotipati (cosa rimasta nella politica italiana, vedi Casini-Prodi-Luxuria: il bello, il comunista, il transgender) ed una recitazione imbarazzante (ancora: Bertinotti, Berlusconi, Gabriella Carlucci), è interessante la leggerezza narrativa e la costruzione degli intrecci, basate su dinamiche del periodo.
La parodia è quasi sempre il carattere della vicenda, sono riproposti i film o i personaggi dell’attualità: il pavido Bruno Sacchi (Fabrizio Bracconeri, oggi guardia giurata di Forum) interpreterà Rambo, oppure Chicco Lazzaretti, pluriripetente, praticamente trentenne, partecipa alla trasmissione Superstrike, condotta da Marco Columbro, vero reuccio della TV.
Ma c’è anche la cronaca che penetra nella fabula: durante una festa in casa di Sharon Zampetti, figlia di un industriale milanese, Camillo Zampetti (Guido Nicheli, da poco scomparso), irrompe la polizia tributaria. Il successo è talmente penetrante che le grandi marche trasformano intere scene in spot veri e propri. E’ il caso dell’Algida, che impone agli attori lo slogan "cuore di panna" mentre trangugiano un cornetto. Oppure la Opel che fa dire a Chicco, di fronte alla sua Corsa: "Che auto spaziosa, e che motore!".
La seconda serie è addirittura sponsorizzata dallo snack Raider. Un concorso si basava sulla presenza dello snack all’interno della puntata. La terza stagione vede i ragazzi all’università. Alcuni attori si stufano, se ne vanno o vengono cacciati: l’università fa questi scherzi. Il prodotto crolla nell’89.
Come il comunismo ha regalato sogni: il sogno di una televisione stupidissima, non volgare, coraggiosa, che lascia il posto a quella degli anni ’90: intelligentissima, volgare e pavida. E’ giusto che alcune cose non siano uscite vive dagli anni Ottanta.
A parte l’utilizzo di personaggi estremamente stereotipati (cosa rimasta nella politica italiana, vedi Casini-Prodi-Luxuria: il bello, il comunista, il transgender) ed una recitazione imbarazzante (ancora: Bertinotti, Berlusconi, Gabriella Carlucci), è interessante la leggerezza narrativa e la costruzione degli intrecci, basate su dinamiche del periodo.
La parodia è quasi sempre il carattere della vicenda, sono riproposti i film o i personaggi dell’attualità: il pavido Bruno Sacchi (Fabrizio Bracconeri, oggi guardia giurata di Forum) interpreterà Rambo, oppure Chicco Lazzaretti, pluriripetente, praticamente trentenne, partecipa alla trasmissione Superstrike, condotta da Marco Columbro, vero reuccio della TV.
Ma c’è anche la cronaca che penetra nella fabula: durante una festa in casa di Sharon Zampetti, figlia di un industriale milanese, Camillo Zampetti (Guido Nicheli, da poco scomparso), irrompe la polizia tributaria. Il successo è talmente penetrante che le grandi marche trasformano intere scene in spot veri e propri. E’ il caso dell’Algida, che impone agli attori lo slogan "cuore di panna" mentre trangugiano un cornetto. Oppure la Opel che fa dire a Chicco, di fronte alla sua Corsa: "Che auto spaziosa, e che motore!".
La seconda serie è addirittura sponsorizzata dallo snack Raider. Un concorso si basava sulla presenza dello snack all’interno della puntata. La terza stagione vede i ragazzi all’università. Alcuni attori si stufano, se ne vanno o vengono cacciati: l’università fa questi scherzi. Il prodotto crolla nell’89.
Come il comunismo ha regalato sogni: il sogno di una televisione stupidissima, non volgare, coraggiosa, che lascia il posto a quella degli anni ’90: intelligentissima, volgare e pavida. E’ giusto che alcune cose non siano uscite vive dagli anni Ottanta.
Fabrizio Aurilia