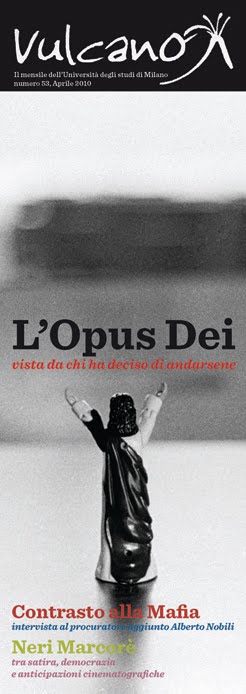21 luglio 2010
Editoriale luglio 2010

16 luglio 2010
LONTANO DAGLI OCCHI

Entro la fine del 2010 quasi mille persone saranno i soggetti di un trasloco forzato. Resta da chiarire la meta.
“Fino a tre, quattro anni fa” Continua Pagani: “Sulla stampa i dati sull'entità degli insediamenti zingari apparivano decisamente gonfiati, per far percepire la situazione come una vera emergenza”. Ora invece è in corso il fenomeno opposto, si tende a minimizzare, a diminuire il numero degli insediamenti, così che le risorse vengano indirizzate ai pochi che il comune riconosce. Gli altri vengono come “cancellati”. 
Si sta diffondendo una moda bipartisan: chiudere i campi nomadi. L'idea reclamizzata è chiudere i “ghetti” per offrire sistemazioni migliori, che offrano anche una migliore integrazione. “In realtà si tratta di una campagna di carattere demagogico” Osserva Pagani. Al di là delle motivazioni di carattere sociologico e culturale e quelle più banalmente veniali, il vicepresidente dell'associazione pone anche delle perplessità di carattere pratico: “Anche dove la popolazione rom si è stabilita in regolari abitazioni sussistono gravi fenomeni di emarginazione, si pensi per esempio alla zona del porto di Genova o a via Padova qui a Milano. Non è tanto il tetto che hai sulla testa, quanto la qualità della vita”.
Maurizio parla anche della gestione autoritaria con cui viene trattata la cosiddetta emergenza. Partendo dal presupposto che far rispettare un regolamento è un punto di partenza fondamentale, pone l'accento sulle modalità, in particolare sulle pratiche, a volte molto violente, che accompagnano gli sgomberi. “Spesso lo sgombero vero e proprio viene preannunciato dall'arrivo della polizia, che attua una serie di pratiche intimidatorie, tra cui la minaccia di togliere i bambini alle famiglie”. E il rischio di sottrazione dei bambini, per motivi più o meno validi, è in effetti elevatissimo.
Infatti la questione minori è uno degli aspetti che desta maggiore preoccupazione. Alla domanda se il diritto allo studio dei bambini viene in qualche modo considerato quando si prende la decisione di sgomberare un campo Maurizio Pagani rispondo in modo deciso: “Assolutamente no”.
Laura Carli
Opera Nomadi è una “associazione con finalità di solidarietà sociale e di tutela dei diritti”, nata a Bolzano nel 1963 e divenuta poi nazionale. Da allora si occupa di sottrarre all’emarginazione e inserire nella collettività gruppi di Rom e Sinti, promuovendo la loro partecipazione attiva alla vita politica, sociale e culturale tramite vari progetti, tra i quali un corso di sartoria e uno di cucina e la presenza di educatori e mediatori culturali nelle scuole per seguire l’educazione dei minori.
Contatti: www.operanomadimilano.org
La scuola del quasi obbligo
 I bambini sono iscritti principalmente alla scuola primaria, alla scuola media si registra già un calo e pochissimi ragazzi proseguono oltre nella loro istruzione. Ciò che è più grave, tuttavia, è il fatto che durante il loro percorso questi bambini incontrano molte difficoltà e poche persone e strutture disposte realmente ad aiutarli: spesso vengono abbandonati a loro stessi o inseriti in programmi di studio diversi da quelli del resto della classe, così che capita che in quarta o quinta elementare non abbiano ancora imparato a leggere e scrivere, o comunque si trovino ad uscire dalla scuola con una preparazione inferiore a quella dei loro compagni.
I bambini sono iscritti principalmente alla scuola primaria, alla scuola media si registra già un calo e pochissimi ragazzi proseguono oltre nella loro istruzione. Ciò che è più grave, tuttavia, è il fatto che durante il loro percorso questi bambini incontrano molte difficoltà e poche persone e strutture disposte realmente ad aiutarli: spesso vengono abbandonati a loro stessi o inseriti in programmi di studio diversi da quelli del resto della classe, così che capita che in quarta o quinta elementare non abbiano ancora imparato a leggere e scrivere, o comunque si trovino ad uscire dalla scuola con una preparazione inferiore a quella dei loro compagni.Alla base della loro difficoltà sta una differenza culturale di fondo: mentre la nostra cultura si basa su una tradizione prevalentemente scritta e ciò si riflette nelle modalità di apprendimento, la cultura rom è orale, come anche la lingua che li identifica come gruppo etnico, il romanes o romanì. Gli studi linguistici fanno derivare questo idioma dalle varianti popolari del sanscrito e riscontrano analogie con i dialetti oggi parlati nell’India del Nord Ovest. In seguito, nel tragitto che ha portato le popolazioni rom verso l’Europa nell’ VIII/XII secolo, essa ha subito numerose variazioni e ancora oggi è molto diversificata al suo interno. In Italia non è considerata una minoranza linguistica, ed ha subito moltissimo l’influsso dei nostri dialetti. La tendenza generale è però quella di acquisire la lingua del paese di adozione, come è accaduto per i rom della Romania. Ancora oggi non sono stati compiuti studi esaustivi su questa lingua, e non esiste una grammatica o una versione standard: la mancanza di una codificazione va naturalmente collegata alla base unicamente orale e alla forte varietà interna. Il sistema scolastico però non si è approcciato in modo consono a questa difficoltà di metodo: a fronte della evidente necessità di fornire un sostegno linguistico ai bambini qualcuno ha invece ritenuto che la diversità fosse da considerarsi un deficit da “sanare” e a Pavia alcuni insegnanti sostengono che sarebbe necessario un intervento di neuropsichiatria infantile. Ci sono dei fondi statali per il supporto educativo dei bambini rom nelle scuole, ma in generale la strategia è sempre stata quella di istituire dei laboratori a parte per colmare le loro lacune. In pratica, oltre a non fornire un livello di istruzione adeguato, questo strumento ha finito per portare a un’ulteriore esclusione dei bambini, che passano più tempo fuori dalla classe che insieme ai loro compagni, e svolgono attività separate.

Quello che manca, dice Maurizio Pagani di Opera Nomadi, è “un intervento di mediazione sociale. L’associazionismo cattolico sminuisce la centralità di questa opzione e la sostituisce con un imprinting culturale che categorizza l’altro come qualcuno che ha solo deficit.” Invece è necessario un rapporto di incontro culturale, anche con le famiglie: “ Quanto meno si interagisce tanto meno l’educazione riesce. Dove si è sperimentato un intervento più ampio anche coinvolgendo i genitori in attività lavorative si sono riscontrati risultati migliori.” Nel campo di Rho, dove è attiva l’associazione, tutti i bambini vanno a scuola e con un progetto di recupero anche alcune madri hanno conseguito il diploma di scuola media. L’associazione paga il viaggio e i libri. “La mancanza di un’esperienza positiva acquisita – spiega Pagani - impedisce l’innescarsi di un processo di emulazione”: anche per questo la situazione scolastica in molti altri campi è di tutt’altro genere. Resta il fatto che il principale impedimento alla scolarizzazione sono le possibilità economiche e il problema dell’abitazione, soprattutto quando la pratica degli sgomberi interrompe forzatamente il percorso di istruzione dei minori, oltre che un contesto sociale violento e problematico.
Irene Nava
Visita al campo di Rho
 Il campo di Rho è uno di quegli esempi di insediamenti nomadi che poco hanno a che vedere con il concetto di “ghetto” descritto negli ultimi tempi dalla cronaca. Si presenta come un’area circondata da zone agricole e complessi industriali sorti di recente che hanno, nel tempo, sottratto sempre più spazio all'area abitativa.
Il campo di Rho è uno di quegli esempi di insediamenti nomadi che poco hanno a che vedere con il concetto di “ghetto” descritto negli ultimi tempi dalla cronaca. Si presenta come un’area circondata da zone agricole e complessi industriali sorti di recente che hanno, nel tempo, sottratto sempre più spazio all'area abitativa.La zona è prevalentemente verde e alterna spazi curati ad altri lasciati incolti. I complessi abitativi, tra roulotte e container, sono rimasti pochi e molte sono le aree lasciate vuote in seguito agli sgomberi.
Inizialmente gli attuali abitanti erano insediati nei terreni agricoli circostanti, da loro acquistati circa quindici anni fa, dove però, in quanto terreni coltivabili, non era legittima la costruzione di alcun tipo di edificio.
Poi, tre anni, fa la giunta comunale ha concesso il permesso per l’apertura del campo. Il progetto originario prevedeva delle baite, ma prevalse la più economica scelta dei container.
Da circa un anno è in corso un graduale processo di svuotamento del campo attraverso la revoca del permesso di occupazione della piazzola, spesso in seguito a motivazioni pretestuose e attraverso metodi intimidatori. Al momento la popolazione è composta da circa trentacinque persone, tra cui quindici bambini, tutti regolarmente iscritti a scuola.
In tutto si possono contare un paio di roulotte e circa cinque prefabbricati dalle porte in lamiera. All’interno le abitazioni si presentano in modo diversificato a seconda delle possibilità delle famiglie, un dettaglio comune a tutte però è l'angolino votivo, con foto della madonna, candele e fiori: una sorta di piccolo altarino domestico.
Il richiamo religioso, più mistico-rituale che propriamente cristiano, ritorna anche all'esterno, con una piccola cappella di forma piramidale, edificata dagli abitanti del campo, di confessione ortodossa, per “ingraziarsi il clero locale” e decorata su tutta la superficie con immagini sacre di santi e di papi.
L'attenzione per gli oggetti di decorazione è presente in tutto il campo: in ogni abitazione mensole e nicchie ospitano ninnoli di vario genere, di carattere più o meno sacro. Quasi un oggetto di culto appare in particolare il modellino di una villa, che troneggia appoggiato sull'armadio in casa di Angelina. Si tratta dell'abitazione che la sua famiglia stava costruendo a Belgrado, una villa grande ed elaborata dall'arc
 hitettura un po' orientale, che suo marito ha voluto riprodurre in scala ed esporre in bella vista.
hitettura un po' orientale, che suo marito ha voluto riprodurre in scala ed esporre in bella vista.Andrea invece vive con i suoi sei fratelli in un'abitazione più modesta. Ha dodici anni e frequenta la prima media, non sa però se riuscirà a terminare con regolare frequenza l’anno scolastico perché il furgoncino con cui i volontari di Opera Nomadi accompagnavano i bambini a scuola è fermo per problemi burocratici di non imminente risoluzione. Alla domanda se sarà o meno promosso quest'anno, risponde incerto che non lo sa, che ha recuperato l'insufficienza in fisica ma non quella in matematica. Sulle sue aspirazioni future ha le idee più chiare: vorrebbe fare “quello che cura i bambini” o il calciatore. Anche Andrea è vittima del cliché italiano del mito della carriera calcistica, mentre parla gioca a P.E.S e racconta del suo goal da centrocampo e dei suoi allenamenti, curati da una volontaria, ex calciatrice del Milan.
Giuliana invece finirà le medie quest'anno ed è una dei pochi ragazzi che ha intenzione di proseguire negli studi: frequenterà una scuola professionale per parrucchieri a Milano. E' una ragazza estroversa, dall'aspetto molto curato, dimostra più dei suoi quattordici anni.
Nel tardo pomeriggio l'atmosfera si vivacizza improvvisamente per il ritorno dei bambini da scuola. E' più tardi del solito perché, con il pulmino inutilizzabile, i ragazzi sono dovuti tornare a piedi. Una volta a casa, confrontano quaderni e calligrafie, fanno a gara a chi scrive meglio e un paio di bambini mostrano orgogliosi la foto di classe; uno in particolare, affascinato dall'aspetto meta-fotografico, non vuole essere immortalato senza. Dopo i primi minuti, passati a discutere della scuola e dei compagni, l'aspetto del gioco puro ha il sopravvento e i ragazzi si concentrano sui loro svaghi abituali.
La giornata di scuola è conclusa ma, con il pulmino fermo, i giorni
 dalla fine di maggio alla conclusione dell'anno scolastico restano incerti. La frequenza sarà sporadica e per lo più basata su mezzi di fortuna.
dalla fine di maggio alla conclusione dell'anno scolastico restano incerti. La frequenza sarà sporadica e per lo più basata su mezzi di fortuna.Lo stesso obbligo di scolarizzazione, sancito a livello nazionale, nel caso dei ragazzi dei campi nomadi è affidato alla discrezione personale e all'arte di arrangiarsi, all'iniziativa individuale e al lavoro dei volontari. Da parte delle istituzioni, nonostante l' “emergenza nomadi” dichiarata due anni fa, che prevedeva anche proposte riguardo ai giovani e all'istruzione, sembra regnare il completo disinteresse.
12 luglio 2010
Intervista a Paolo Saporiti
PAOLO SAPORITI è un cantautore milanese proveniente dal mondo sempre più prolifico della “indie alternative”. La musica che propone è di grande qualità, emozionante, suggestiva, intimista ma soprattutto originale! Un intreccio musicale in cui la ricerca e l’attenzione per i dettagli si uniscono alla profondità dei testi. Arpeggi di chitarre creano uno sfondo su cui la splendida voce di Paolo crea melodie sottili, ma allo stesso tempo profonde e graffianti.
“ALONE”, il suo nuovo lavoro E’ PRODOTTO E ARRANGIATO DA TEHO TEARDO acclamato compositore di colonne sonore (Il Divo, La ragazza del lago) e recente vincitore del David di Donatello 2009 per “Il Divo”.  Teho ha saputo arricchire con i suoi arrangiamenti il tessuto sonoro di Paolo senza snaturarne l’anima. Nel disco Teardo ha suonato diversi strumenti tra cui piano rhodes, chitarre, glockenspiel, basso ed elettronica e diretto l’orchestrazione di una quartetto d’archi.
Teho ha saputo arricchire con i suoi arrangiamenti il tessuto sonoro di Paolo senza snaturarne l’anima. Nel disco Teardo ha suonato diversi strumenti tra cui piano rhodes, chitarre, glockenspiel, basso ed elettronica e diretto l’orchestrazione di una quartetto d’archi.
Lo abbiamo incontrato qui a Milano. Questo è un ampio estratto della lunga e interessantissima chiacchierata che ci ha concesso.
Stavo pensando a un film-documentario su Neil Young (Year of the Horse, NdA) mi ha colpito moltissimo una cosa, Neil guardando in telecamera dice: per questo album sono puro, non sono mai stato così puro da trent’anni a questa parte. Mi sei venuto in mente tu. Quanto questa frase ti può riguardare, diventare puro in quello che fai, farsi nudo?
Direi che il 90% di quello che faccio è quello. Anche il modo di porsi sul palco…io credo che a un uomo ‘Universal’ interessi il fatto che io sorrida e che mi ponga in un certo modo, tale da non creare contrasto; io credo invece fermamente nell’esatto contrario. Sei in difficoltà con i tuoi problemi, sei in una situazione ‘umana’, ti manifesti per l’uomo che sei, non ti manifesti per l’uomo che si suppone dovresti essere sul palcoscenico.
Cerco di rispettare al massimo questa cosa, anche diventando controproducente, provi tensione, fai vedere la tensione, non fai vedere che sei perfetto e che gigioneggi con il pubblico; la guerra che voglio fare io è quella lì. Dire: va bene, ce la sta facendo uno che evita di assumere posture, evita di sfruttare quei cliché che alla fine rovinano la musica, nel senso che non arrivi mai a qualche cosa…e ciò crea difficoltà, perché la gente è talmente abituata a uno che fa il sorrisino, è talmente abituata a uno che invita all’applauso, è talmente abituata a uno che è perfetto nelle sue cagate, che questo non viene riconosciuto e viene anche preso quasi come un problema…ah sei timido…ah non ti interessa il pubblico, sei presuntuoso..ma che cazzo c’entra? Sto pensando ai miei problemi e a risolvere il mio ascolto. Quello che non capiscono è che tu stai vivendo in quel momento lì. Questo il teatro lo insegna. E il successo di una recitazione buona vuol dire convivere con quelle cose lì, quindi viverti il momento per quello che è.
In un’intervista ho letto ‘La musica a volte mi ha aiutato più delle persone’. Mi sono molto riconosciuto e mi ha anche un po’ spaventato.
Bè, se ti dico Jeff Buckley… è una persona che nella mia vita mi ha aiutato. Come mi hanno aiutato tantissimi. Comunque c’è un aspetto della solitudine che fa parte credo del percorso dell’uomo e, nello specifico, di uno che vuole fare arte. E credo sia molto meglio confrontarti con la solitudine che affrontar la vita ‘normalmente’, cioè proponendoti verso l’esterno sempre senza trovar dei punti di riflessione. La musica, secondo me, in questo contribuisce, perché se tu appena appena la ami sai che condividerla è un mondo tuo, soprattutto questo genere ha bisogno di un te riflessivo. Ti costruisci il tuo mondo e la musica ti aiuta a sostenerlo. In più poi, storicamente, in alcuni momenti, la musica mi ha dato una grandissima mano. L’idea di famiglia che non ho perché i miei sono divorziati, automaticamente me la sono creata con gli amici musicisti, gli amici scrittori…
Un ambiente nuovo ti sei scelto….
Sì, ti crei una nicchia. Infatti mia madre mi prende in giro perché da quando sono piccolo, i miei movimenti nello spazio, andare al mare, andare in montagna, andare di qua, andare di là, significano portarmi dietro i miei dieci libri e i miei venti dischi; e ovunque arrivo piazzo quella roba e la mia giornata è fatta. Credo sia la caratteristica di uno che ha dentro questo tipo di cose. Hai bisogno comunque di quello che ti sostiene e ti permette di essere te stesso.
Che musica ascoltavi da ragazzino?
Sono venuto su con Crosby, Stills e Nash, Neil Young, James Taylor, Cockburn da matti. Cockburn è un ascolto di mio zio, gli altri sono tantissimo ascolti di mio padre che praticamente fin da piccolo mi ha indirizzato. E poi lui aveva quello che poi faccio io, ascoltava la musica in cuffia; e anche quello è uno “schema di gioco” abbastanza importante, perché comunque quello mi permette di perdere oltremodo i riferimenti del quotidiano. Poi Joni Mitchell, Tom Waits anche quello prima maniera chitarra e voce, e poi pian piano da lì…uno spostamento leggero.
Infatti, oggi cosa stai ascoltando? Che cosa ti colpisce di più?
Ho cercato di aprirmi, sono cambiato, nel senso che prima ero proprio: Nick Drake, Cockburn…ma dopo un po’ hai consumato quel tipo di mondo. Oggi lo ricerco nei pochi che lo ripropongono, ho ascoltato parecchio jazz, mi hanno colpito i trombettisti, probabilmente avevo bisogno di una seconda voce, di qualche cosa molto simile al cantato, quindi Miles Davis. Mi piace moltissimo anche questo Clifford Brown che ho scoperto lavora tantissimo con Max Roach, batterista pazzesco. Ho trovato quelle piccole cose che il mondo indie ti sa dare, cioè la ricerca del suono, la ricerca dell’essenza della musica, mica tante note ma tutta roba corposa, ben presente. Ho ascoltato un po’ di classica, Wagner, che devo dire non conoscevo, e mi sono sembrati entusiasmanti i Die Prelude.
Ora vorrei entrare un po’ più nello specifico dell’album (‘Alone’ 2010, Universal Classics & Jazz). Conta tanto la presenza o l’ assenza di Dio nelle canzoni del tuo nuovo lavoro? Mi sembra che una specie di dialogo in questo senso ci sia. Qualcosa che riguarda il superiore, l’Alto. Che pervade qualsiasi cosa o si fa sentire la sua presenza-assenza, e le conseguenze di entrambe le cose…
Io non so definirmi rispetto a questo, è da poco che sto cercando di trovare le parole in italiano, dette da altri o non. Sto leggendo Kierkegaard e Nietzsche, cioè sto cercando di fare quello che non ho fatto da giovane e automaticamente riscontri il fatto che tutte quelle cose che attraverso le canzoni vengono fuori normalmente sono state messe molto bene in parole e pensieri da altre persone. Non so dare un nome a quello che provo, nel senso che non so dirti se sono credente, ateo, ho una sensazione molto forte che però è legata alla fede, al credere, non è legata a un’entità. Io credo che sia quello la cosa di cui l’uomo ha bisogno o di cui è fatto, non è tanto la cosa in cui credi, ma è il fatto di credere. Punto. Lo vuoi chiamare sogno, lo vuoi chiamare ideale, lo vuoi chiamare passione, l’importante è che un uomo si confronti con una cosa più grossa di lui, e poi a quel punto gli puoi dare il nome di Dio o quello che vuoi, ma è quella cosa lì che secondo me si sente nelle mie canzoni. Io credo talmente tanto nell’esserci, nell’esser presente, e quel presente lì secondo me deriva da qualcosa di superiore.
C’è una specie di filo rosso nella tua tematica, nella tua produzione? Stavo pensando al tema della trasformazione, la volontà di lasciarsi andare ma con una specie di nostalgia per qualcosa che si è lasciato, cioè la volontà di lasciarsi trasformare dagli eventi e guardare però indietro in maniera un po’ spaventata quello che si è lasciato, cioè una specie di ‘in bilico’…
È la mia essenza direi. La mia storia biografica soprattutto.
Mi sono segnato dei passi dall’album nuovo: “quando son tornato con tutto quello in cui mi sono trasformato” (da “Look into my eyes”), “Tenetemi così, pulito./ Conservatemi nel vuoto./ Tenetemi a lungo/ dove io stesso non ho saputo stare” (da “I could die alone”) e poi “Ricorda me e tutto quello che ho perso”. Quindi io ho pensato che da una parte c’è una volontà di fare parte delle cose, lasciarsi andare, lasciarsi scorrere da qualche parte, ma anche un trattenersi…
Io credo che faccia parte del godere la vita nelle sue difficoltà, uno dei punti nodali è quando i miei hanno divorziato. Sono figlio di divorziati, e quello, per chiunque ne abbia questa esperienza, sa che è una cosa grossa, come la perdita di un di un genitore, che poi ho provato. Sono tutti punti enormi della tua esistenza, però proprio perché sono punto enormi sono punto di crescita, di svolta, di trasformazione. Il successo come uomo, secondo me, è riuscire a vivere a pieno tutti queste fasi. Sei stato costretto ad abbandonare un qualche cosa, ma la tua capacità è di riuscire ad essere talmente elastico e talmente creativo nel tuo modo di stare al mondo, che quella è una perdita, e nell’istante dopo c’è la costruzione di qualcosa. Quindi io vivo di queste cose; ho cercato di impostare così la mia vita, attraverso gli studi di psicologia e tutte le forme di terapia che ho sperimentato, sempre in maniera autodidatta, nel senso che sono passato attraverso tantissime cose, senza mai perdermi in una completamente, cercando di mantenere un percorso che io mi ero più o meno prestabilito, in modo tale da cogliere da alcuni gli aspetti nodali e poi gli altri lasciarli pure agli altri.
Cambiando argomento: sì cambiando forse davvero argomento rispetto a quello che stavamo dicendo, tu hai scritto una canzone che si chiama ”We are the fuel”, perché? mi piace, mi sono immaginato una specie di ambiente e una specie di orgoglio, una specie di ‘cazzo, però noi stiamo qui, ci siamo…e ne siamo orgogliosi’, me la sono immaginata così questa cosa.
Ed è proprio così: ”We are the fuel”, nel senso siamo la benzina per il mondo, la mia idea in quel momento era quella, poi dico anche, quando verrà il ‘lightning’, il momento dell’illuminazione, sperando in qualche modo di poter contribuire alla causa. Stava funzionando molto bene il live come sensazione interiore con Francesca al violoncello (NdA, Francesca Ruffilli, violoncellista che ha contribuito alla realizzazione di “Just Let It happen” e nell’attività live del 2008 e parte del 2009), avevo comprato il banjo da una settimana, e mi sono uscite due canzoni che reputo molto belle e molto ricche di quello che era quel momento lì, quindi ”We are the fuel” è quello: siamo al concerto, stiamo suonando, bene, noi siamo la benzina, ma il pubblico è la stessa cosa per noi, c'è veramente la speranza che possa essere la fiammella per qualche cosa.
Nella tua produzione è qualcosa che arricchisce un po’ il panorama…
Fino a quel momento rimango molto introspettivo, senza osare una cosa così.
Questa è una delle prime canzoni sociali, ho detto, che ho scritto. E io non sono sociale; sono sociale nel momento in cui credi sia importante per l’individuo per arricchire la società. Io ho sempre creduto in questo.
Sì, forse in questa canzone il referente è un ‘noi’…
Sì, perché c’è l’idea di gruppo che si stava risviluppando, con Francesca c’era un rapporto per cui era l’assemblaggio che stava funzionando particolarmente, ed era un po’ di tempo che la cosa andava così, due anni, quindi iniziava ad avere il peso di un gruppo. Con tutti i musicisti cerco un po’ di avere quell’atteggiamento, nei limiti del ‘Paolo Saporiti cantautore’ cerco di sviluppare una parità: anche sul palco lo vedi, non sono io davanti e il musicista dietro, cerco di stare sullo stesso fronte, tanto che il musicista prende pieno spazio nei momenti di solo, poi ho anche la fortuna di beccare questi musicisti che riescono ad essere solisti mentre stanno accompagnando me, non è gente che sta facendo il servizietto, la cosa bellissima è questa.
Mi ha colpito quando ti ho visto a Osnago, quanto rispetto avevi riguardo a chi stavi ascoltando, per il lavoro di un altro e una complessità che ci sta dietro. Altre volte hai detto “per me è un piacere aprire un concerto di…”, purtroppo non mi sembra una cosa scontata, non si fa caso a questa cura…
Ma guarda che questo è proprio il mondo di questa cosa (ride), è fatto da persone non abituate a rispettare né sé stesse né gli altri, fa parte del discorso di prima del concerto. È rispetto dire che sei su un palcoscenico e non fingi, è rispetto per te stesso e per gli altri. Io l’altro giorno ho suonato a Napoli e ho visto gente che fa quell’errore lì: siccome è scomodo fare il cantautore triste ed intimista, allora deve arrivare quello che "aléé…adesso si balla". Perché? La gente non è abituata ad abitarsi, il teatro questo lo insegna tanto. Renzo Casali, che è il mio insegnante di teatro della Comuna Baires, la prima cosa che insegna, a livello teatrale, ma secondo me a livello umano, è proprio attraverso l’improvvisazione, entrare in uno spazio con una richiesta che tu hai rispetto a quello spazio e alla persona che abita quello spazio, e avere comunque rispetto alla tua esigenza di piccolo uomo, di essere ascoltato, di chiedere qualche cosa, di non chiederlo, comunque avere l’attenzione a 360° su quello che incontri li dentro, su quello che è lo spazio e su quello che è la persona, quello che prova lui; quindi tu nonostante abbia una carica altissima per chiedere qualche cosa, che sia attenzione o altro, prima affronti dov’è quella persona, poi fai la tua domanda. Questa cosa qua è una roba che se facessero teatro in quei termini alle elementari, alle medie, al liceo, secondo me cambieresti l’umanità, perché a quel punto c’è una forma di rispetto in ogni cosa
Cantautore milanese, la maggior parte dei concerti in Italia tranne la parentesi in Irlanda,come mai l’inglese?
È un riflesso fondamentalmente. Ascolto musica americana da quando ho due anni, se non prima, forse dalla pancia, e non ho dentro di me i suoni italiani. “Gelo” (NdA la dodicesima e ultima traccia di ‘ALONE’ e l’unica in italiano incisa finora da Paolo) è un pezzo in italiano, però è come se fosse un inglese o un americano che canta in italiano, non hai una sensazione di italianità vera e propria, ma non è fastidio verso l’Italia. Il mio corpo nasce da quella musica là. Se io adesso mi metto a improvvisare faccio dei suoni che sono americani. Poi invece capita la situazione in cui esce l’italiano strettamente perché ho una cosa molto quadrata, molto diretta da dire, e allora c’è quell’esigenza lì che prevede la comprensione istantanea da parte di chi può ascoltare, e allora c’è l’italiano. Ma di base non voglio che uno capisca mentre io sto cantando. Mentre io sto cantando al concerto non voglio che la gente capisca le parole che sto dicendo in quel momento, preferisco che, come è successo l’altro giorno, Dario Ballantini che ha detto ‘non ho bisogno di capire quello che dice lui, sono già dentro a quelle emozioni’. Per me questo è un successo, cioè non è un problema che uno mi dica che non capisce l’inglese o perché lo pronuncio male altrimenti, e fa parte del discorso di prima, vuol dire non avere ancora capito che la vita è fatta di emozioni e di aver voglia di condividere quelle emozioni o no. La parola è importantissima, però può essere un secondo momento di riflessione rispetto a quella che può essere una performance live di un musicista.
Ti sei ricreduto sulla tecnologia ‘moderna’, anni fa mi ricordo che mi avevi accennato quanto eri restio nei suoi confronti
Ho scoperto il valore di internet e della facilitazione che ti crea per un progetto: essere lui a Roma, io a Milano, gli mando il brano, lui lo riceve la mattina, lo ascolta, registra, me lo rimanda la sera e io glielo rimando il giorno dopo, e fare un disco così è una roba pazzesca. Però siamo comunque legati a certe cose, e il disco è registrato su bobina.
Dove si può trovare il tuo disco a Milano?
Adesso Feltrinelli, Fnac, Buscemi, insomma tutti i negozi, almeno quelli di musica.
Giovedì 4 febbraio 2010, Milano
Alessandro Manca
1 luglio 2010
1 luglio MILANO CONTRO IL BAVAGLIO
 "In difesa della giustizia, dell'informazione e della libertà di espressione su Internet". Milano si mobilita contro il disegno di legge Alfano, approvato con voto di fiducia al Senato.
"In difesa della giustizia, dell'informazione e della libertà di espressione su Internet". Milano si mobilita contro il disegno di legge Alfano, approvato con voto di fiducia al Senato.Giovedì 1 luglio, concentramento in piazza Cordusio alle ore 18,30.
Partecipate numerosi!