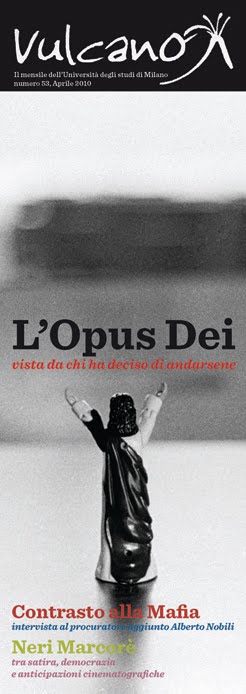La sessantatreesima edizione del Festival di Venezia si è rivelata tra le più interessanti degli ultimi anni, soprattutto perché in grado di restituire un’immagine fedele di ciò che è oggi il cinema, o meglio i cinemi. Abbiamo tentato di farcene un’idea seguendo la Panoramica dei film del festival a Milano, che al solito si è tenuta nei giorni immediatamente successivi alla mostra in vari cinema della nostra città.
Parliamo innanzitutto del cinema italiano, presente con numerosi e per lo più notevoli titoli, come i film di Crialese, Spada, De Seta. Unica, peraltro tragica, eccezione il film di Tavarelli (Non prendere impegni stasera), che si spera riduca la sua visibilità a qualche passaggio notturno su Canale Cinque, subito dopo “Distretto di Polizia”.
Poi la conferma dell’ormai imprescindibile declino in cui (av)versa il cinema francese. Sept ans di Hattu ne è stato ammorbante esempio: solitissimo triangolo pseudosessuale questa volta in salsa carceraria (mah!), solitissime trascuratezze formal-concettuali, solitissimo risvolto scolasticamente sociale.
Il cinema argentino, invece, continua a raccontarsi con film avvolgenti, sinceri, significanti. Il titolo migliore è stato El Amarillio, opera prima di Sergio Mazza, in cui si finisce come per perdersi, tra ricerca poetica d’immagine e musiche d’oltremare, e d’oltreanima. Peccato sia anch’esso (come tutto il resto del contemporaneo cinema argentino) destinato al silenzio e all’invisibilità nostrana.
Clamorosamente assente è stato il cinema iraniano, che non è andato oltre un film(accio) senza arte né parte (Have you another apple?). Forse anche questo è il segno (triste) di quella crisi prima di tutto politica che sta logorando uno dei paesi cinematograficamente più significativi degli ultimi dieci anni.
Inaspettata e fulminante, come sempre, la presenza del cinema nordico. Questa volta con un film (?) del celebre attore Christoffer Boe, che in Offscreen tenta un esperimento al limite dell’(auto)lesionismo: filmarsi 24 ore su 24, nel disperato tentativo di spingersi nell’oltrecinema. Restano così in video (con dolore vero) quei frammenti impossibili che sempre, che ogni momento si sprecano nel vento degli istanti.
Come al solito, anche se in modo minore rispetto agli anni passati, il cinema orientale l’ha fatta da padrone, fra cui ha spiccato l’incommensurabile Johnnie To col suo nuovo film Exiled, che resterà al solito confinato nei festival, data la cecità della distribuzione nostrana.
Infine, passando al cinema angloamericano, non ci sono state particolari sorprese, causa la delusione del De Palma di Black Dahlia e lo Stone di World Trade Center che non ha particolarmente colpito. Si salva l’inglese The Queen, bella pellicola di stampo classico che comunque non stravolge canoni o temi particolari.
Vi chiederete perché non abbiamo parlato di molti film importanti: non abbiamo parlato dell’Inland Empire di Lynch, né del Leone d’oro Still life, neppure di Children of Men di Cuaròn, o dei cartoni animati d’autore orientali. Beh, semplicemente perché non sono stati inclusi nelle proiezioni milanesi, gravi mancanze che pregiudicano il giudizio complessivo sui film di quest’anno. Inoltre gli orari di proiezioni impossibili da far coincidere e la lontananza fra un cinema e l’altro rendono difficile il seguire di questa manifestazione, che rimane ben organizzata, ma con margini di miglioramento che la potrebbero rendere un evento impedibile.
RECENSIONI
FANGZHU (EXILED) – Johnnie To - ****
 1998, isola di Macao. La colonia portoghese è in procinto di tornare sotto il controllo cinese e la confusione regna sovrana anche negli ambienti criminali. Quattro gangster, amici per la pelle, si ritrovano a causa della ricomparsa del loro compagno Wo, fuggito dal mondo del crimine per farsi una famiglia, e che ora deve essere ucciso causa ordine irrevocabile del loro boss. Quando però anch’essi si accorgeranno di essere stati traditi dal loro stesso capo, inizia la caccia all’uomo…Strepitoso film del maestro di genere Johnnie To, una favola epica di amicizia virile, disperazione e sangue, il tutto però condito dall’ ironia che ultimamente solo il cinema orientale ci sa regalare ( basti pensare alla scena iniziale del film). Magistrale
1998, isola di Macao. La colonia portoghese è in procinto di tornare sotto il controllo cinese e la confusione regna sovrana anche negli ambienti criminali. Quattro gangster, amici per la pelle, si ritrovano a causa della ricomparsa del loro compagno Wo, fuggito dal mondo del crimine per farsi una famiglia, e che ora deve essere ucciso causa ordine irrevocabile del loro boss. Quando però anch’essi si accorgeranno di essere stati traditi dal loro stesso capo, inizia la caccia all’uomo…Strepitoso film del maestro di genere Johnnie To, una favola epica di amicizia virile, disperazione e sangue, il tutto però condito dall’ ironia che ultimamente solo il cinema orientale ci sa regalare ( basti pensare alla scena iniziale del film). MagistraleJAK-PAE (City of Violence) - Ryoo Seung-wan -***1/2
THE QUEEN – Stephen Frears - ***1/2
La storia dei giorni immediatamente successivi alla morte di Lady Diana attraverso gli occhi dei tre effettivi protagonisti di quei tragici giorni: la Regina Elisabetta II, Tony Blair ed infine il popolo britannico. La pellicola, a differenza di quanto detto più monarchica che mai, parte dal fatto di cronaca per tracciare un ritratto lucido di quella che è la difficoltà del potere antico e consolidato (appunto, la monarchia) di confrontarsi col potere nuovo e riformatore (il Blair di quel periodo, e soprattutto la nuova importanza rivestita dal popolo). Finale al vetriolo per una Helen Mirren tanto brava da identificarsi fisicamente con la regina senza assomigliarle. Regale
BLACK DAHLIA – Brian de Palma - **1/2
 Mescolando un reale fatto di cronaca, l’orribile morte dell’aspirante attrice Elizabeth Short negli anni ’30, col libro omonimo di James Ellroy, il film narra delle indagini dei due poliziotti ex pugili Josh Hartnett e Aaron Eckart, che nel frattempo trovano anche il tempo di contendersi la moglie di quest’ultimo Scarlet Johannson. La mano è sempre quella di de Palma, e si vede nelle bellissime scelte di taglio registico, ma sul piano narrativo il film si sfilaccia in un attimo fra scene di sesso etero e omosessuale, autocitazioni, e più in generale attraverso una storia che sa di vecchio. Bello come può essere bello un mobile antico. Stantio
Mescolando un reale fatto di cronaca, l’orribile morte dell’aspirante attrice Elizabeth Short negli anni ’30, col libro omonimo di James Ellroy, il film narra delle indagini dei due poliziotti ex pugili Josh Hartnett e Aaron Eckart, che nel frattempo trovano anche il tempo di contendersi la moglie di quest’ultimo Scarlet Johannson. La mano è sempre quella di de Palma, e si vede nelle bellissime scelte di taglio registico, ma sul piano narrativo il film si sfilaccia in un attimo fra scene di sesso etero e omosessuale, autocitazioni, e più in generale attraverso una storia che sa di vecchio. Bello come può essere bello un mobile antico. Stantio
La pellicola è stata tacciata da più parti di americanismo, in realtà è semplicemente la ricostruzione delle emozioni provate dagli statunitensi, e in modo minore anche da noi, in quei tragici giorni, senza prendere una posizione politica, evitandone la questione. Dignitoso
NUOVOMONDO di Emanuele Crialese - ****
Crialese scompone la Storia (l’emigrazione sicula verso l’America nei primi del novecento) in immagini che vogliono essere (prima di tutto e per una volta) cinema: e allora il nuovo mondo è innanzitutto verdura gigante trascinata da bambini su zolle di terra, e poi monete che si fanno foglie e con suoni d’argento ci ricoprono gli occhi, e poi fiume di latte in cui dimenticare il proprio sogno. Mentre l’America vera resta solo nebbia, da spiare, ma solo per un attimo, attraverso finestrelle poste troppo in alto. Migrante
LA STELLA CHE NON C’E’ di Gianni Amelio - ***
Viaggio attento e malinconico attraverso i contraddittori segni della Cina: ma ad Amelio interessa soprattutto raccontare di due solitudini, di due passaggi [l’operaio italiano specializzato (un magnifico Castellitto) senza più lavoro, la ragazza cinese senza più/senza mai dimensione]. Poteva essere un capolavoro, ma Amelio stecca il finale, consegnando tutto ad una sequenza posticcia quanto inutilizzabile. Bastava fermarsi sul volto di Castellitto che sommessamente piange, mentre la chiatta su acqua dal colore di terra lo nasconde agli occhi, dietro la prossima ansa di fiume. Intermittente
LETTERE DAL SAHARA di Vittorio De Seta - ****
LA RIEDUCAZIONE di Davide Alfonsi, Alessandro Fusto, Denis Malagnino - ****
COME L’OMBRA di Marina Spada - ****½
L’UDIENZA E’ APERTA di Vincenzo Marra ***½
A cura di Mattia Mariotti e Davide Bonacina