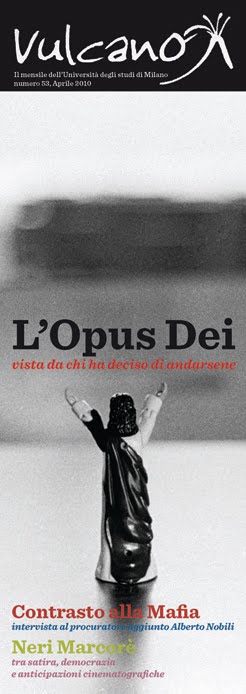PAOLO SAPORITI è un cantautore milanese proveniente dal mondo sempre più prolifico della “indie alternative”. La musica che propone è di grande qualità, emozionante, suggestiva, intimista ma soprattutto originale! Un intreccio musicale in cui la ricerca e l’attenzione per i dettagli si uniscono alla profondità dei testi. Arpeggi di chitarre creano uno sfondo su cui la splendida voce di Paolo crea melodie sottili, ma allo stesso tempo profonde e graffianti.
“ALONE”, il suo nuovo lavoro E’ PRODOTTO E ARRANGIATO DA TEHO TEARDO acclamato compositore di colonne sonore (Il Divo, La ragazza del lago) e recente vincitore del David di Donatello 2009 per “Il Divo”.  Teho ha saputo arricchire con i suoi arrangiamenti il tessuto sonoro di Paolo senza snaturarne l’anima. Nel disco Teardo ha suonato diversi strumenti tra cui piano rhodes, chitarre, glockenspiel, basso ed elettronica e diretto l’orchestrazione di una quartetto d’archi.
Teho ha saputo arricchire con i suoi arrangiamenti il tessuto sonoro di Paolo senza snaturarne l’anima. Nel disco Teardo ha suonato diversi strumenti tra cui piano rhodes, chitarre, glockenspiel, basso ed elettronica e diretto l’orchestrazione di una quartetto d’archi.
Lo abbiamo incontrato qui a Milano. Questo è un ampio estratto della lunga e interessantissima chiacchierata che ci ha concesso.
Stavo pensando a un film-documentario su Neil Young (Year of the Horse, NdA) mi ha colpito moltissimo una cosa, Neil guardando in telecamera dice: per questo album sono puro, non sono mai stato così puro da trent’anni a questa parte. Mi sei venuto in mente tu. Quanto questa frase ti può riguardare, diventare puro in quello che fai, farsi nudo?
Direi che il 90% di quello che faccio è quello. Anche il modo di porsi sul palco…io credo che a un uomo ‘Universal’ interessi il fatto che io sorrida e che mi ponga in un certo modo, tale da non creare contrasto; io credo invece fermamente nell’esatto contrario. Sei in difficoltà con i tuoi problemi, sei in una situazione ‘umana’, ti manifesti per l’uomo che sei, non ti manifesti per l’uomo che si suppone dovresti essere sul palcoscenico.
Cerco di rispettare al massimo questa cosa, anche diventando controproducente, provi tensione, fai vedere la tensione, non fai vedere che sei perfetto e che gigioneggi con il pubblico; la guerra che voglio fare io è quella lì. Dire: va bene, ce la sta facendo uno che evita di assumere posture, evita di sfruttare quei cliché che alla fine rovinano la musica, nel senso che non arrivi mai a qualche cosa…e ciò crea difficoltà, perché la gente è talmente abituata a uno che fa il sorrisino, è talmente abituata a uno che invita all’applauso, è talmente abituata a uno che è perfetto nelle sue cagate, che questo non viene riconosciuto e viene anche preso quasi come un problema…ah sei timido…ah non ti interessa il pubblico, sei presuntuoso..ma che cazzo c’entra? Sto pensando ai miei problemi e a risolvere il mio ascolto. Quello che non capiscono è che tu stai vivendo in quel momento lì. Questo il teatro lo insegna. E il successo di una recitazione buona vuol dire convivere con quelle cose lì, quindi viverti il momento per quello che è.
In un’intervista ho letto ‘La musica a volte mi ha aiutato più delle persone’. Mi sono molto riconosciuto e mi ha anche un po’ spaventato.
Bè, se ti dico Jeff Buckley… è una persona che nella mia vita mi ha aiutato. Come mi hanno aiutato tantissimi. Comunque c’è un aspetto della solitudine che fa parte credo del percorso dell’uomo e, nello specifico, di uno che vuole fare arte. E credo sia molto meglio confrontarti con la solitudine che affrontar la vita ‘normalmente’, cioè proponendoti verso l’esterno sempre senza trovar dei punti di riflessione. La musica, secondo me, in questo contribuisce, perché se tu appena appena la ami sai che condividerla è un mondo tuo, soprattutto questo genere ha bisogno di un te riflessivo. Ti costruisci il tuo mondo e la musica ti aiuta a sostenerlo. In più poi, storicamente, in alcuni momenti, la musica mi ha dato una grandissima mano. L’idea di famiglia che non ho perché i miei sono divorziati, automaticamente me la sono creata con gli amici musicisti, gli amici scrittori…
Un ambiente nuovo ti sei scelto….
Sì, ti crei una nicchia. Infatti mia madre mi prende in giro perché da quando sono piccolo, i miei movimenti nello spazio, andare al mare, andare in montagna, andare di qua, andare di là, significano portarmi dietro i miei dieci libri e i miei venti dischi; e ovunque arrivo piazzo quella roba e la mia giornata è fatta. Credo sia la caratteristica di uno che ha dentro questo tipo di cose. Hai bisogno comunque di quello che ti sostiene e ti permette di essere te stesso.
Che musica ascoltavi da ragazzino?
Sono venuto su con Crosby, Stills e Nash, Neil Young, James Taylor, Cockburn da matti. Cockburn è un ascolto di mio zio, gli altri sono tantissimo ascolti di mio padre che praticamente fin da piccolo mi ha indirizzato. E poi lui aveva quello che poi faccio io, ascoltava la musica in cuffia; e anche quello è uno “schema di gioco” abbastanza importante, perché comunque quello mi permette di perdere oltremodo i riferimenti del quotidiano. Poi Joni Mitchell, Tom Waits anche quello prima maniera chitarra e voce, e poi pian piano da lì…uno spostamento leggero.
Infatti, oggi cosa stai ascoltando? Che cosa ti colpisce di più?
Ho cercato di aprirmi, sono cambiato, nel senso che prima ero proprio: Nick Drake, Cockburn…ma dopo un po’ hai consumato quel tipo di mondo. Oggi lo ricerco nei pochi che lo ripropongono, ho ascoltato parecchio jazz, mi hanno colpito i trombettisti, probabilmente avevo bisogno di una seconda voce, di qualche cosa molto simile al cantato, quindi Miles Davis. Mi piace moltissimo anche questo Clifford Brown che ho scoperto lavora tantissimo con Max Roach, batterista pazzesco. Ho trovato quelle piccole cose che il mondo indie ti sa dare, cioè la ricerca del suono, la ricerca dell’essenza della musica, mica tante note ma tutta roba corposa, ben presente. Ho ascoltato un po’ di classica, Wagner, che devo dire non conoscevo, e mi sono sembrati entusiasmanti i Die Prelude.
Ora vorrei entrare un po’ più nello specifico dell’album (‘Alone’ 2010, Universal Classics & Jazz). Conta tanto la presenza o l’ assenza di Dio nelle canzoni del tuo nuovo lavoro? Mi sembra che una specie di dialogo in questo senso ci sia. Qualcosa che riguarda il superiore, l’Alto. Che pervade qualsiasi cosa o si fa sentire la sua presenza-assenza, e le conseguenze di entrambe le cose…
Io non so definirmi rispetto a questo, è da poco che sto cercando di trovare le parole in italiano, dette da altri o non. Sto leggendo Kierkegaard e Nietzsche, cioè sto cercando di fare quello che non ho fatto da giovane e automaticamente riscontri il fatto che tutte quelle cose che attraverso le canzoni vengono fuori normalmente sono state messe molto bene in parole e pensieri da altre persone. Non so dare un nome a quello che provo, nel senso che non so dirti se sono credente, ateo, ho una sensazione molto forte che però è legata alla fede, al credere, non è legata a un’entità. Io credo che sia quello la cosa di cui l’uomo ha bisogno o di cui è fatto, non è tanto la cosa in cui credi, ma è il fatto di credere. Punto. Lo vuoi chiamare sogno, lo vuoi chiamare ideale, lo vuoi chiamare passione, l’importante è che un uomo si confronti con una cosa più grossa di lui, e poi a quel punto gli puoi dare il nome di Dio o quello che vuoi, ma è quella cosa lì che secondo me si sente nelle mie canzoni. Io credo talmente tanto nell’esserci, nell’esser presente, e quel presente lì secondo me deriva da qualcosa di superiore.
C’è una specie di filo rosso nella tua tematica, nella tua produzione? Stavo pensando al tema della trasformazione, la volontà di lasciarsi andare ma con una specie di nostalgia per qualcosa che si è lasciato, cioè la volontà di lasciarsi trasformare dagli eventi e guardare però indietro in maniera un po’ spaventata quello che si è lasciato, cioè una specie di ‘in bilico’…
È la mia essenza direi. La mia storia biografica soprattutto.
Mi sono segnato dei passi dall’album nuovo: “quando son tornato con tutto quello in cui mi sono trasformato” (da “Look into my eyes”), “Tenetemi così, pulito./ Conservatemi nel vuoto./ Tenetemi a lungo/ dove io stesso non ho saputo stare” (da “I could die alone”) e poi “Ricorda me e tutto quello che ho perso”. Quindi io ho pensato che da una parte c’è una volontà di fare parte delle cose, lasciarsi andare, lasciarsi scorrere da qualche parte, ma anche un trattenersi…
Io credo che faccia parte del godere la vita nelle sue difficoltà, uno dei punti nodali è quando i miei hanno divorziato. Sono figlio di divorziati, e quello, per chiunque ne abbia questa esperienza, sa che è una cosa grossa, come la perdita di un di un genitore, che poi ho provato. Sono tutti punti enormi della tua esistenza, però proprio perché sono punto enormi sono punto di crescita, di svolta, di trasformazione. Il successo come uomo, secondo me, è riuscire a vivere a pieno tutti queste fasi. Sei stato costretto ad abbandonare un qualche cosa, ma la tua capacità è di riuscire ad essere talmente elastico e talmente creativo nel tuo modo di stare al mondo, che quella è una perdita, e nell’istante dopo c’è la costruzione di qualcosa. Quindi io vivo di queste cose; ho cercato di impostare così la mia vita, attraverso gli studi di psicologia e tutte le forme di terapia che ho sperimentato, sempre in maniera autodidatta, nel senso che sono passato attraverso tantissime cose, senza mai perdermi in una completamente, cercando di mantenere un percorso che io mi ero più o meno prestabilito, in modo tale da cogliere da alcuni gli aspetti nodali e poi gli altri lasciarli pure agli altri.
Cambiando argomento: sì cambiando forse davvero argomento rispetto a quello che stavamo dicendo, tu hai scritto una canzone che si chiama ”We are the fuel”, perché? mi piace, mi sono immaginato una specie di ambiente e una specie di orgoglio, una specie di ‘cazzo, però noi stiamo qui, ci siamo…e ne siamo orgogliosi’, me la sono immaginata così questa cosa.
Ed è proprio così: ”We are the fuel”, nel senso siamo la benzina per il mondo, la mia idea in quel momento era quella, poi dico anche, quando verrà il ‘lightning’, il momento dell’illuminazione, sperando in qualche modo di poter contribuire alla causa. Stava funzionando molto bene il live come sensazione interiore con Francesca al violoncello (NdA, Francesca Ruffilli, violoncellista che ha contribuito alla realizzazione di “Just Let It happen” e nell’attività live del 2008 e parte del 2009), avevo comprato il banjo da una settimana, e mi sono uscite due canzoni che reputo molto belle e molto ricche di quello che era quel momento lì, quindi ”We are the fuel” è quello: siamo al concerto, stiamo suonando, bene, noi siamo la benzina, ma il pubblico è la stessa cosa per noi, c'è veramente la speranza che possa essere la fiammella per qualche cosa.
Nella tua produzione è qualcosa che arricchisce un po’ il panorama…
Fino a quel momento rimango molto introspettivo, senza osare una cosa così.
Questa è una delle prime canzoni sociali, ho detto, che ho scritto. E io non sono sociale; sono sociale nel momento in cui credi sia importante per l’individuo per arricchire la società. Io ho sempre creduto in questo.
Sì, forse in questa canzone il referente è un ‘noi’…
Sì, perché c’è l’idea di gruppo che si stava risviluppando, con Francesca c’era un rapporto per cui era l’assemblaggio che stava funzionando particolarmente, ed era un po’ di tempo che la cosa andava così, due anni, quindi iniziava ad avere il peso di un gruppo. Con tutti i musicisti cerco un po’ di avere quell’atteggiamento, nei limiti del ‘Paolo Saporiti cantautore’ cerco di sviluppare una parità: anche sul palco lo vedi, non sono io davanti e il musicista dietro, cerco di stare sullo stesso fronte, tanto che il musicista prende pieno spazio nei momenti di solo, poi ho anche la fortuna di beccare questi musicisti che riescono ad essere solisti mentre stanno accompagnando me, non è gente che sta facendo il servizietto, la cosa bellissima è questa.
Mi ha colpito quando ti ho visto a Osnago, quanto rispetto avevi riguardo a chi stavi ascoltando, per il lavoro di un altro e una complessità che ci sta dietro. Altre volte hai detto “per me è un piacere aprire un concerto di…”, purtroppo non mi sembra una cosa scontata, non si fa caso a questa cura…
Ma guarda che questo è proprio il mondo di questa cosa (ride), è fatto da persone non abituate a rispettare né sé stesse né gli altri, fa parte del discorso di prima del concerto. È rispetto dire che sei su un palcoscenico e non fingi, è rispetto per te stesso e per gli altri. Io l’altro giorno ho suonato a Napoli e ho visto gente che fa quell’errore lì: siccome è scomodo fare il cantautore triste ed intimista, allora deve arrivare quello che "aléé…adesso si balla". Perché? La gente non è abituata ad abitarsi, il teatro questo lo insegna tanto. Renzo Casali, che è il mio insegnante di teatro della Comuna Baires, la prima cosa che insegna, a livello teatrale, ma secondo me a livello umano, è proprio attraverso l’improvvisazione, entrare in uno spazio con una richiesta che tu hai rispetto a quello spazio e alla persona che abita quello spazio, e avere comunque rispetto alla tua esigenza di piccolo uomo, di essere ascoltato, di chiedere qualche cosa, di non chiederlo, comunque avere l’attenzione a 360° su quello che incontri li dentro, su quello che è lo spazio e su quello che è la persona, quello che prova lui; quindi tu nonostante abbia una carica altissima per chiedere qualche cosa, che sia attenzione o altro, prima affronti dov’è quella persona, poi fai la tua domanda. Questa cosa qua è una roba che se facessero teatro in quei termini alle elementari, alle medie, al liceo, secondo me cambieresti l’umanità, perché a quel punto c’è una forma di rispetto in ogni cosa
Cantautore milanese, la maggior parte dei concerti in Italia tranne la parentesi in Irlanda,come mai l’inglese?
È un riflesso fondamentalmente. Ascolto musica americana da quando ho due anni, se non prima, forse dalla pancia, e non ho dentro di me i suoni italiani. “Gelo” (NdA la dodicesima e ultima traccia di ‘ALONE’ e l’unica in italiano incisa finora da Paolo) è un pezzo in italiano, però è come se fosse un inglese o un americano che canta in italiano, non hai una sensazione di italianità vera e propria, ma non è fastidio verso l’Italia. Il mio corpo nasce da quella musica là. Se io adesso mi metto a improvvisare faccio dei suoni che sono americani. Poi invece capita la situazione in cui esce l’italiano strettamente perché ho una cosa molto quadrata, molto diretta da dire, e allora c’è quell’esigenza lì che prevede la comprensione istantanea da parte di chi può ascoltare, e allora c’è l’italiano. Ma di base non voglio che uno capisca mentre io sto cantando. Mentre io sto cantando al concerto non voglio che la gente capisca le parole che sto dicendo in quel momento, preferisco che, come è successo l’altro giorno, Dario Ballantini che ha detto ‘non ho bisogno di capire quello che dice lui, sono già dentro a quelle emozioni’. Per me questo è un successo, cioè non è un problema che uno mi dica che non capisce l’inglese o perché lo pronuncio male altrimenti, e fa parte del discorso di prima, vuol dire non avere ancora capito che la vita è fatta di emozioni e di aver voglia di condividere quelle emozioni o no. La parola è importantissima, però può essere un secondo momento di riflessione rispetto a quella che può essere una performance live di un musicista.
Ti sei ricreduto sulla tecnologia ‘moderna’, anni fa mi ricordo che mi avevi accennato quanto eri restio nei suoi confronti
Ho scoperto il valore di internet e della facilitazione che ti crea per un progetto: essere lui a Roma, io a Milano, gli mando il brano, lui lo riceve la mattina, lo ascolta, registra, me lo rimanda la sera e io glielo rimando il giorno dopo, e fare un disco così è una roba pazzesca. Però siamo comunque legati a certe cose, e il disco è registrato su bobina.
Dove si può trovare il tuo disco a Milano?
Adesso Feltrinelli, Fnac, Buscemi, insomma tutti i negozi, almeno quelli di musica.
Giovedì 4 febbraio 2010, Milano
www.paolosaporiti.com/
www.myspace.com/paolosaporiti
Alessandro Manca

 i Smith, Dead Boys, New York Dolls e Stooges, il gruppo di Iggy Pop).
i Smith, Dead Boys, New York Dolls e Stooges, il gruppo di Iggy Pop).
 Teho ha saputo arricchire con i suoi arrangiamenti il tessuto sonoro di Paolo senza snaturarne l’anima. Nel disco Teardo ha suonato diversi strumenti tra cui piano rhodes, chitarre, glockenspiel, basso ed elettronica e diretto l’orchestrazione di una quartetto d’archi.
Teho ha saputo arricchire con i suoi arrangiamenti il tessuto sonoro di Paolo senza snaturarne l’anima. Nel disco Teardo ha suonato diversi strumenti tra cui piano rhodes, chitarre, glockenspiel, basso ed elettronica e diretto l’orchestrazione di una quartetto d’archi.
 Compagno di strada fino all’ultimo del Partito Comunista Francese (nelle settimane precendenti la morte si era speso per la campagna elettorale del Front de Gauche, coalizione guidata dal PCF, nelle elezioni regionali), Ferrat non vi aderirà mai formalmente, mantenendo costantemente un profilo critico, talvolta sferzante, non senza venire influenzato dalle contraddizioni e dalle trasformazioni della linea del partito negli ultimi decenni.
Compagno di strada fino all’ultimo del Partito Comunista Francese (nelle settimane precendenti la morte si era speso per la campagna elettorale del Front de Gauche, coalizione guidata dal PCF, nelle elezioni regionali), Ferrat non vi aderirà mai formalmente, mantenendo costantemente un profilo critico, talvolta sferzante, non senza venire influenzato dalle contraddizioni e dalle trasformazioni della linea del partito negli ultimi decenni.