 4 giugno 1968. Los Angeles. All’Hotel Ambassador lo staff del senatore Robert Kennedy aspetta con impazienza i risultati delle primarie, in cui si sfidano il fratello del presidente statunitense assassinato appena 5 anni prima a Dallas e Mc Cathy. In palio c’è la possibilità di correre alla Casa Bianca. Attorno, per i corridoi e le stanze dell’albergo, si muove una miriade di personaggi. Dal vecchio portiere cui è recentemente morta la moglie (Antony Hopkins) che sfida a scacchi un saggio collega (Harry Belafonte), al direttore dell’albergo (William H. Macy) che licenzia con orgoglio un dirigente razzista e carognesco (Christian Slater) e tradisce la moglie (un’inedita Sharon Stone, in versione parrucchiera dei divi) con una giovane centralinista (Heather Graham). Dalla cantante alcolizzata e sul viale del tramonto (Demi Moore), al pacifico broker (Martin Sheen) che combatte con la superficialità della moglie (Helen Hunt), collezionista di opere di Pop-Art. E poi i due giovani sostenitori dei democratici che prendono Lsd e dimenticano l’impegno politico, la ragazza che sposa un giovane amico solo per salvarlo dalla chiamata dello Zio Sam, ed il giovane attivista nero che vede nell’ascesa del candidato democratico una speranza per gli afroamericani. E ancora il cameriere messicano che rinuncia alla partita di baseball dei sogni per un caso di quotidiano sfruttamento, il cuoco di colore ormai disilluso dall’America che ha ucciso Martin Luther King e la giornalista cecoslovacca che nessuno prende in considerazione perché proveniente da un paese considerato “comunista”, malgrado la svolta democratica di Dubcek.
4 giugno 1968. Los Angeles. All’Hotel Ambassador lo staff del senatore Robert Kennedy aspetta con impazienza i risultati delle primarie, in cui si sfidano il fratello del presidente statunitense assassinato appena 5 anni prima a Dallas e Mc Cathy. In palio c’è la possibilità di correre alla Casa Bianca. Attorno, per i corridoi e le stanze dell’albergo, si muove una miriade di personaggi. Dal vecchio portiere cui è recentemente morta la moglie (Antony Hopkins) che sfida a scacchi un saggio collega (Harry Belafonte), al direttore dell’albergo (William H. Macy) che licenzia con orgoglio un dirigente razzista e carognesco (Christian Slater) e tradisce la moglie (un’inedita Sharon Stone, in versione parrucchiera dei divi) con una giovane centralinista (Heather Graham). Dalla cantante alcolizzata e sul viale del tramonto (Demi Moore), al pacifico broker (Martin Sheen) che combatte con la superficialità della moglie (Helen Hunt), collezionista di opere di Pop-Art. E poi i due giovani sostenitori dei democratici che prendono Lsd e dimenticano l’impegno politico, la ragazza che sposa un giovane amico solo per salvarlo dalla chiamata dello Zio Sam, ed il giovane attivista nero che vede nell’ascesa del candidato democratico una speranza per gli afroamericani. E ancora il cameriere messicano che rinuncia alla partita di baseball dei sogni per un caso di quotidiano sfruttamento, il cuoco di colore ormai disilluso dall’America che ha ucciso Martin Luther King e la giornalista cecoslovacca che nessuno prende in considerazione perché proveniente da un paese considerato “comunista”, malgrado la svolta democratica di Dubcek.
Nel raccontare le ultime ore di vita di Robert Kennedy, Emilio Esteves, figlio d’arte (suo padre è Martin Sheen) sceglie sapientemente di non mostrare mai il vero protagonista della vicenda, se non attraverso immagini di repertorio. Le parole dei discorsi di Bobby, che rimbalzano dagli schermi televisivi accessi nelle stanze dell’albergo, fanno da sottofondo a un affresco corale su un’America che insieme al giovane senatore democratico sta perdendo anche la propria innocenza. Un affresco alla Altman, che strizza l’occhio a “Nashville” (anche lì il film si chiudeva con colpi di pistola verso un candidato, seppur di segno radicalmente opposto). Ma tuttavia senza l’amarezza, il disincanto, la cruda ironia del maestro. Dal tono invece elegiaco, malinconico per ciò che avrebbe potuto essere, non è stato, e non sarà più.
Dallo schermo riaffiorano allora le angosce, le frustrazioni, le nevrosi (ma anche i lati positivi) di una società che sta sprofondando verso il baratro del Vietnam, del Watergate e di una delle più grandi crisi sociali e politiche che ha mai dovuto affrontare.
Non mancano ovviamente i riferimenti ai giorni nostri: dalla vicenda del messicano Jose che allude al muro della vergogna e alle leggi anti-immigrazione del governo Bush all’ovvio parallelo tra guerra del Vietnam e guerra in Iraq. L’America traballante di ieri, sembra dire il film, assomiglia terribilmente a quella di oggi, incamminatasi, come i soldati nel finale di “Full Metal Jacket”, verso un inferno terreno tutt’altro che metaforico.
Bobby appartiene quindi a un filone di film d’impegno civile, di simpatie squisitamente democratiche, che già in passato ha prodotto pellicole come “Tutti gli uomini del presidente” o “Philadelphia” e in tempi più recenti “Good night and good luck” o “Syriana”. Non rinuncia completamente all’idea del sogno americano (si veda la tirata del personaggio interpretato da Laurence Fishburne al giovane messicano Josè, che tira in ballo nientemeno che Rè Artù e i cavalieri della Tavola Rotonda), ma sa anche dipingere i sogni spezzati di un epoca, in maniera nient’affatto trionfale. Il linguaggio è sonoramente hollywoodiano ma il finale è tutt’altro che retorico - o perlomeno ben lontano dalla retorica solenne a cui il cinema americano corrente ci ha abituato.
Francesco Zurlo




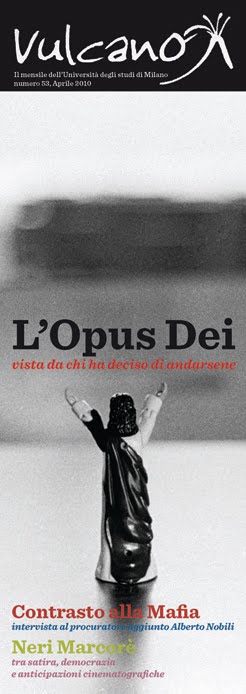















Nessun commento:
Posta un commento