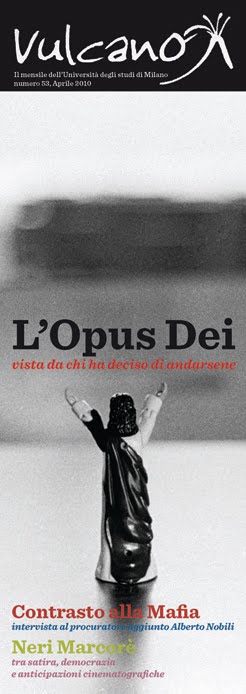Qualche giorno fa abbiamo conosciuto Marco Arioli, il responsabile lombardo di CasaPound, una delle più giovani organizzazioni politiche di estrema destra (anche se loro preferiscono farsi chiamare “fascisti del nuovo millennio”). La loro appartenenza politica suscita quel misto di spavento e fastidio, comune nei confronti di chi manifesta un pensiero e un agire radicali. La rivendicazione fascista poi, è ciò che maggiormente offende chi proprio non capisce cosa ci sia di tanto affascinante nel ventennio, tanto da ispirare indegne celebrazioni. Abbiamo però cercato di mettere da parte i nostri giudizi (o pregiudizi?), ascoltando e cercando di capire.
Per quanto riguarda CP, si tratta non tanto e  non solo di un riflusso nostalgico verso un passato eroico, quanto piuttosto del tentativo di “sviluppare in maniera organica un progetto e una struttura politica nuova, che proietti nel futuro il patrimonio ideale e umano che il Fascismo italiano ha costruito con immenso sacrificio”. Il loro simbolo è la tartaruga: “l’animale che per eccellenza rappresenta la longevità”.
non solo di un riflusso nostalgico verso un passato eroico, quanto piuttosto del tentativo di “sviluppare in maniera organica un progetto e una struttura politica nuova, che proietti nel futuro il patrimonio ideale e umano che il Fascismo italiano ha costruito con immenso sacrificio”. Il loro simbolo è la tartaruga: “l’animale che per eccellenza rappresenta la longevità”.
L'associazione nasce a Roma nel 2003, con l'occupazione di un edificio che ne diverrà la sede, da parte di alcuni ragazzi, guidati da Simone di Stefano. Oggi l’esponente di riferimento è Gianluca Iannone, protagonista dell’esperimento che ha poi ispirato la nascita di CP, Casa Montag, e “teorico delle occupazioni”, oltre che fondatore del gruppo rock ZetaZeroAlfa.
L'approdo a Milano, recente, è stato assai travagliato. Prima come Cuore Nero - ma la sede di Viale Certosa è stata incendiata prima dell'inaugurazione, nel 2007, da antagonisti di sinistra - e infine come Casa Pound.
Il nome è, ovviamente, un tributo a Ezra Pound, uno dei grandi poeti del novecento, impegnato collateralmente nello sviluppo di una teoria economica “contro l'Usura”. Celebre la sua prigionia a Pisa, dove fu prima internato in un campo, e poi considerato pazzo grazie ad una perizia truccata proprio per salvargli la vita.
Al centro della sua speculazione economica è il cosiddetto “mutuo sociale”, ossia la costruzione da parte dello Stato su terreni pubblici, di case da vendere a prezzo di costo alle famiglie, senza passare per il cappio delle banche, l'ambizione è quella di dare una risposta concreta all'emergenza abitativa. Altro punto cardinale, la statalizzazione della banche: da quando “l'emissione della moneta è stata scippata alla Comunità Nazionale a favore di gruppi privati” i cittadini sono tenuti “sotto strozzo”, attraverso un calcolato e controllato aumento del debito. Si tratta dell'altrimenti detto “signoraggio bancario”, tema non ignoto anche al pensiero radicale di sinistra - fino a qualche tempo fa, era tema anche degli spettacoli di Beppe Grillo (anche se è considerato da molti una delle maggiori bufale via web).
-Comunque la si pensi, non è facile neanche riuscire a parlarne - si lamenta Marco, - ci ho provato nelle scuola, ma il commento alle mie parole era sempre lo stesso: “porco fascista!”. L'antifascismo è un mito duro a morire, come dottrina unica professata dai sedicenti progressisti di sinistra, tolta la quale molto spesso resta il nulla. Siamo pur sempre il paese incapace di fare i conti con la propria storia. -
Senza che questo significhi rinunciare all’antifascismo, va loro riconosciuto merito per le iniziative migliori, come la distribuzione della spesa ai poveri o, in Abruzzo, la collaborazione nella ricostruzione di Poggio Picenze, che ha spinto il sindaco - di centro sinistra - ad affidare loro l'organizzazione di una biblioteca, dedicata, ovviamente, a Ezra Pound. Per l'occasione è stato pensato lo slogan: “Libri come mattoni, per ricostruire l'Abruzzo”.
Per colpa di un nostro inveterato pregiudizio, restiamo stupiti dalla disponibilità di Marco a parlarci di ciò che fanno, e di ciò che pensano. Sembrerà banale, deamicisiano, ma anche il suo entusiasmo stupisce: non sono molte le persone entusiaste del loro impegno politico. Chi avesse il coraggio di andare oltre l’iniziale rigetto, è proprio su questo che dovrebbe interrogarsi, su come sia possibile spiegare quest'impegno. Va riconosciuta la loro capacità di mobilitazione, specialmente se confrontata con il nulla di chi, non credendo più in nulla, nulla fa perché un frammento di ciò che non piace cambi.
 Per sfatare qualche mito, è bene segnalare la loro posizione, non comune (almeno fra le parallele organizzazioni politiche di destra), favorevole alla regolarizzazione delle coppie gay. Altrettanto degno di nota il loro antirazzismo, lontano da ogni possibile “caccia all'immigrato”. Anche loro, così come il mondo civile, pensano che il problema non sia mai l'uomo bisognoso di aiuto, ma il fenomeno dell'immigrazione clandestina. Difficile capire se dietro ai bei discorsi corrisponda un reale convincimento, fa comunque piacere sentire parole ragionate.
Per sfatare qualche mito, è bene segnalare la loro posizione, non comune (almeno fra le parallele organizzazioni politiche di destra), favorevole alla regolarizzazione delle coppie gay. Altrettanto degno di nota il loro antirazzismo, lontano da ogni possibile “caccia all'immigrato”. Anche loro, così come il mondo civile, pensano che il problema non sia mai l'uomo bisognoso di aiuto, ma il fenomeno dell'immigrazione clandestina. Difficile capire se dietro ai bei discorsi corrisponda un reale convincimento, fa comunque piacere sentire parole ragionate.
Alla fine della chiaccherata emerge che l’incompatibilità tra le nostre posizioni e quelle del responsabile di Casa Puond su molti temi non ci hanno impedito di ascoltare e di farci ascoltare, e per qualche secondo abbiamo intravisto la possibilità di un dialogo, di un confronto franco, non violento... Non è forse necessario questo per riuscire a realizzare qualcosa di nuovo e, secondo il motto di Confucio, tanto amato da Pound, rinnovare davvero?
Giuseppe Argentieri e Filippo Bernasconi




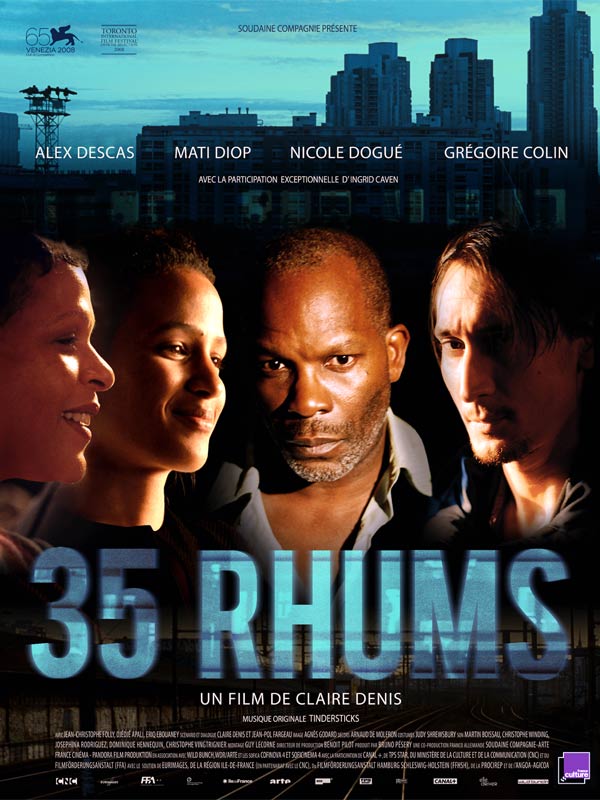

%20WWF-Canon_%20Michel%20ROGGOmedia.jpg)
 Noi cosa possiamo fare? Non è colpa nostra se le grandi industrie distruggono il nostro pianeta per profitto. Tanto per cominciare si possono raccogliere alcuni suggerimenti presenti nel sito del wwf (
Noi cosa possiamo fare? Non è colpa nostra se le grandi industrie distruggono il nostro pianeta per profitto. Tanto per cominciare si possono raccogliere alcuni suggerimenti presenti nel sito del wwf (

 Nel 1988 tre differenti laboratori, ad Oxford, Tucson e Zurigo, hanno effettuato il test del Carbonio 14 per datare un campione del tessuto della Sindone. Il risultato complessivo colloca la fabbricazione della presunta reliquia tra il 1260 e il 1390, proprio il periodo in cui nelle cronache medievali appare per la prima volta il misterioso sudario. Se pensiamo che nella Storia sono circolate una quarantina di altre sindoni, tra le quali la più celebre è quella di Besançon, poi distrutta durante la rivoluzione francese, non è difficile presupporre l’opera di qualche falsario medievale.
Nel 1988 tre differenti laboratori, ad Oxford, Tucson e Zurigo, hanno effettuato il test del Carbonio 14 per datare un campione del tessuto della Sindone. Il risultato complessivo colloca la fabbricazione della presunta reliquia tra il 1260 e il 1390, proprio il periodo in cui nelle cronache medievali appare per la prima volta il misterioso sudario. Se pensiamo che nella Storia sono circolate una quarantina di altre sindoni, tra le quali la più celebre è quella di Besançon, poi distrutta durante la rivoluzione francese, non è difficile presupporre l’opera di qualche falsario medievale.![clip_image002[9] clip_image002[9]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH7xZFRIvcKT8XEAxibwlm7bNSSnol5eMbnEGC7Asai-I1mUj1S2MzyFytkRQzoAE3GUmVMFwPTHuv3nmGSEst7IwSySIhfTs2TYsA0nj0lzHFu5ep1JeZF4YHkKACIqe1KBo4/?imgmax=800)
![clip_image002[7] clip_image002[7]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPeWr6hwlIodsyz_r3_fPkDCNi09yACHx4VBCJgwT4ikwpKJ2M8YCiQ57ofr6FtuQfq03ljtU-65-eDi9B-sRwJTfBBtfn-jVu9vcjMa2ygtkp_a9pevveuKiMP-nAkvINEn4K/?imgmax=800)