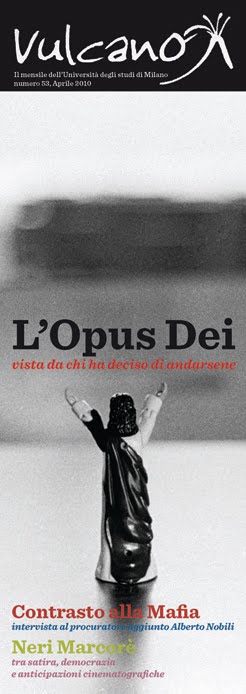Era il 1906 quando, in un sobborgo di Dublino, nasceva Samuel Beckett. Da quella grigia e strana città cominciava la sua vita da studente di letteratura, ma presto un’inquietudine interiore l’avrebbe portato in giro per l’Europa, fino a Parigi, la città della stabilità, coronata da un felice matrimonio e dal vero inizio della sua carriera. È con “
Aspettando Godot” che il mondo artistico e letterario, e soprattutto il pubblico, lo scoprono. Con la rappresentazione dell’opera, avvenuta per la prima volta nel 1953, al Theatre de Babylone di Parigi, si accende l’interesse per questo prolifico autore, si scopre finalmente il suo mondo, dopo innumerevoli rifiuti. È così che comincia, attraverso i rifiuti, “
è nell’insuccesso che io mi sento molto più a mio agio avendo respirato profondamente la sua aria vivificante durante tutta la mia attesa, sino agli ultimi anni. “, dirà Beckett, nella profonda consapevolezza della propria intimità, custodita gelosamente attraverso la riservatezza, e i silenzi, che insieme alle attese dominano e abbracciano le sue opere, circondandole di fascino e mistero. E i misteri dei personaggi, le origini sconosciute, le storie che sembrano sfuggire alla razionalità, portano presto i critici ad inquadrare il suo lavoro nel “
Teatro dell’Assurdo”, a scarnificare i suoi romanzi, alla disperata ricerca di un qualunque messaggio. Ma Beckett, un burbero e scontroso irlandese, rifiuterà per sempre le categorie dei critici, l’arrovellarsi, l’intellettualismo disperato, soffermandosi solo sulla descrizione cruda, pura ed essenziale delle vicende umane dei suoi protagonisti. È dura accettare che dietro alle mille domande che nascono di fronte alle spiazzanti assenze, personificate da Godot, non si nascondono risposte. Le vite strane, alienate, invase con prepotenza dalla solitudine sono poste al centro delle sue produzioni, attraverso i personaggi, da Malone a Bocca, la protagonista di “
Non Io”, uomini e donne, derelitti. Ad incorniciare queste esistenze, tali solo grazie alla parola che l’autore dona alle proprie creature, ecco i luoghi, poveri, quasi vuoti: Il salice di “
Aspettando Godot”, nel nulla in cui si muovono Estragone e Vladimiro, le stanze spoglie dei romanzi, la distesa d’erba in cui è interrata Winnie di “
Giorni Felici”. In ogni particolare sembra riecheggiare questa solitudine, a tratti spaventosa, ma viva, attiva, che ha ancora molto da dire, come sostiene il protagonista de “
L’innominabile”, l’ultima opera della trilogia, portato sulle scene da Gassman nel 1967, che, nel finale, così chiosa: “
…bisogna continuare, non posso continuare, e io continuo”. Sembrano reagire tutti allo stesso modo, questi individui reietti, finiti, eppure ancorati con le unghie all’esistenza, disposti a dire tutto, fino alla fine, ad essere, perché no, felici, a rendere omaggio alla Vita. Beckett non ha mai promesso risposte, e non ha mai dato spiegazioni. Le sue opere sono storie intense, commoventi, divertenti. Fanno pensare. Non regalano certezze. Ed è per questo che tutti gli autori successivi non hanno potuto fare altro che confrontarsi con il genio che ha lasciato nel teatro. Nell’anno del centenario, numerose sono le iniziative per ricordarlo: a Londra e a Dublino, con due festival a lui dedicati, ad Oxford con una serie di letture e riflessioni, mentre a Parigi, fino a giugno 2007, con continue rappresentazioni nei teatri.
Chiara Caprio Pare che l’Inghilterra non si accorgerà del Natale. Fabbriche, uffici, scuole hanno deciso di non esporre simboli che rimandino alla festività. Motivo: non contrariare cittadini di fede musulmana.
Pare che l’Inghilterra non si accorgerà del Natale. Fabbriche, uffici, scuole hanno deciso di non esporre simboli che rimandino alla festività. Motivo: non contrariare cittadini di fede musulmana.