 Questa mostra, iniziata il dicembre dell’anno scorso e che si concluderà il 6 marzo, è una delle ultime attività culturali promosse dal comune di Milano nel 2009, con lo scopo di consolidare i rapporti d’amicizia tra le due culture e porre i visitatori di fronte a orizzonti diversi.
Questa mostra, iniziata il dicembre dell’anno scorso e che si concluderà il 6 marzo, è una delle ultime attività culturali promosse dal comune di Milano nel 2009, con lo scopo di consolidare i rapporti d’amicizia tra le due culture e porre i visitatori di fronte a orizzonti diversi.L’esposizione illustra paraventi, maschere ceramiche, armature e kimoni provenienti dai tre maggiori musei di Tokyo, Kyoto e Osaka e appartenenti a due epoche ben precise: il periodo Mowoyama (1568-1615) e il periodo Edo (1615-1868), conosciuto anche come il “periodo di pace” grazie all’Imperatore Ieyasu, che pose fine alle secolari guerre civili.
Tra i paesi asiatici il Giappone è quello con cui l’Occidente si è inteso meglio. A testimoniarlo sono soprattutto i numerosi scambi d’arte, come è accaduto con gli impressionisti dell’Ottocento oppure con lo stile Liberty, comparso nella nostra parte di mondo solo alla fine del XIX secolo.
Insomma, il sottile filo rosso che collega le diverse aree tematiche della mostra è l’affermarsi della modernità attraverso influssi reciproci tra Oriente e Occidente e, in particolare, evidenzia come la trasformazione moderna della società nipponica avvenne ancor prima dell’apertura politica e culturale verso Ovest.
Il Giappone moderno nasce dall’incontro tra ambiente feudale e samuraico con la nuova borghesia finanziaria e imprenditoriale, generando due fulcri di vitale importanza: Kyoto, la capitale imperiale ed Edo, capitale amministrativa e attuale Tokyo. Un esempio? Il design di un set da picnic, formato da cinque pezzi incastrati in una scatola nera e decorato con elementi naturali rosa su sfondo scuro. Due fattori sono legati al design tradizionale giapponese: la sacralità della materia da un lato, la cura e precisione dell’artigiano dall’altro. Quest’ultima rende il lavoro simile a un rito religioso e, piuttosto che equiparare l’oggetto finito a pura mercanzia, l’artista crea dei contenitori in cui trasmettere la propria umanità, quasi fossero esseri viventi.
Il Giappone moderno nasce dall’incontro tra ambiente feudale e samuraico con la nuova borghesia finanziaria e imprenditoriale, generando due fulcri di vitale importanza: Kyoto, la capitale imperiale ed Edo, capitale amministrativa e attuale Tokyo. Un esempio? Il design di un set da picnic, formato da cinque pezzi incastrati in una scatola nera e decorato con elementi naturali rosa su sfondo scuro. Due fattori sono legati al design tradizionale giapponese: la sacralità della materia da un lato, la cura e precisione dell’artigiano dall’altro. Quest’ultima rende il lavoro simile a un rito religioso e, piuttosto che equiparare l’oggetto finito a pura mercanzia, l’artista crea dei contenitori in cui trasmettere la propria umanità, quasi fossero esseri viventi.

Il rispetto che i giapponesi nutrono per tutto ciò che li circonda deriva dalla religione primogenita giapponese: lo shintoismo, di orientamento animista, dove ogni cosa è un dio e la materia stessa è pervasa da divinità. Lo Shinto rappresenta lo stretto legame tra natura, arti e letteratura giapponesi: i numerosi paraventi ( da osservare e leggere da destra a sinistra, come i manga) raffigurano animali, piante, fiori e paesaggi naturali e richiamano topos letterari ben precisi, a dimostrazione di come già nel Cinquecento la letteratura giapponese fosse all’apice del suo splendore. I componimenti poetici, dai più antichi waka ai più moderni haiku, presentano il tema naturale come principale e superiore a quello umano. Anzi, la vita umana è narrata solo attraverso i cambi di stagione del paesaggio. In questo modo mutano le decorazioni dei kimoni delle donne, le forme delle tazze nella famosa cerimonia del tè oppure i soggetti dei paraventi. Dunque, ogni aspetto del percorso umano è dominato dalla natura, anche il potere e la vita militare: i “pini guerrieri” ,le aquile o le decorazioni delle katane dimostrano quanto la natura possa benissimo esprimere anche sentimenti guerrieri e virili.
In un'altra reparto la mostra richiama l’attenzione del pubblico alla filosofia Zen. Essa si sintetizza con la capacità di cogliere la bellezza del passaggio delle stagioni per poter, in un secondo momento, comprendere la bellezza delle attività umane. Avete presente le numerose rappresentazioni riguardanti i fiori di ciliegio? Questi fiori acquistano significato solo in punto di morte, quando cadono, poiché uno dei punti fondamentali di questo ramo del Buddhismo è l’assenza, il non finito: bisogna saper cogliere il vuoto, il nulla per potersi fissare sui dettagli dell’esistenza.
-ori.jpg) Per quanto riguarda l’influenza occidentale, invece, nell'epoca interessata il principale punto di contatto con l’esterno fu il porto della città di Nagasaki, in collegamento con Olanda e Portogallo. Gli olandesi, chiamati “barbari del Sud”, riuscirono ad esportare la polvere da sparo e le lenti fotografiche e, a differenza dei portoghesi, furono accettati e rispettati. Con questi ultimi invece il dissimile pensiero religioso costituì una barriera culturale insormontabile: i giapponesi non potevano comprendere, tanto meno sopportare, la rigida ortodossia dei gesuiti portoghesi. Comunque dagli stranieri la società nipponica trasse spunti per quanto riguarda l’arte, trasportando sui paraventi il chiaroscuro, per la resa tridimensionale degli oggetti.
Per quanto riguarda l’influenza occidentale, invece, nell'epoca interessata il principale punto di contatto con l’esterno fu il porto della città di Nagasaki, in collegamento con Olanda e Portogallo. Gli olandesi, chiamati “barbari del Sud”, riuscirono ad esportare la polvere da sparo e le lenti fotografiche e, a differenza dei portoghesi, furono accettati e rispettati. Con questi ultimi invece il dissimile pensiero religioso costituì una barriera culturale insormontabile: i giapponesi non potevano comprendere, tanto meno sopportare, la rigida ortodossia dei gesuiti portoghesi. Comunque dagli stranieri la società nipponica trasse spunti per quanto riguarda l’arte, trasportando sui paraventi il chiaroscuro, per la resa tridimensionale degli oggetti.Nonostante la mostra tratti un periodo di tempo che arriva a fine Ottocento, tuttora la società giapponese è sensibile alle proprie origini e tradizioni, benché sia all’avanguardia nel progresso tecnologico. E non solo il patrimonio culturale viene trasmesso alle nuove generazioni, ma esse si riconoscono ancora in queste usanze. Il concetto delle “nostre radici” è basilare in ogni società, non per esaltarne l’antico e legionario pensiero patriottico, ma per permettere agli individui di sviluppare un pensiero critico e acquisire un approccio umano verso l’altro.
Francesca Gabbiadini




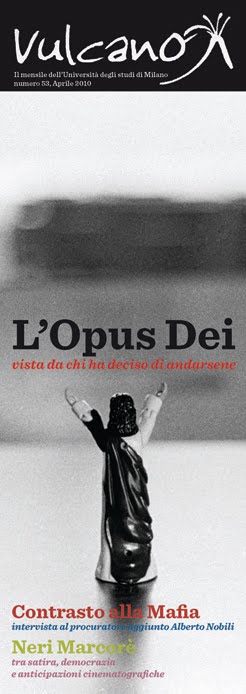















Nessun commento:
Posta un commento