 La montagna è bruna, ancora più bruna nella luce del mezzodì. Mentre il sole si appresta alla discendente parabola verso le stazioni del tramonto, della sera-vespertina e della notte brumosa, resto così, immobile e animato da predisposizione contemplativa, ad osservare l’orizzonte curvo della pianura. Il silenzio è rotto dal ronzare di una miriade di piccoli insetti (coleotteri d’ogni marca e modello, formiche alate e micidiali mosconi minacciosi(micidiali per il dolore che, con caritatevole magnanimità di stampo che definirei “quasi ambrosiano”, dispensano ad ogni puntura)). A tratti, nel concerto d’ali vibranti, c’è gloria anche per qualche sparuto pesce che con un ‘plop’ e una bolla rompe la superficie dello stagno fagocitando un insetto impegnato in un assolo.
La montagna è bruna, ancora più bruna nella luce del mezzodì. Mentre il sole si appresta alla discendente parabola verso le stazioni del tramonto, della sera-vespertina e della notte brumosa, resto così, immobile e animato da predisposizione contemplativa, ad osservare l’orizzonte curvo della pianura. Il silenzio è rotto dal ronzare di una miriade di piccoli insetti (coleotteri d’ogni marca e modello, formiche alate e micidiali mosconi minacciosi(micidiali per il dolore che, con caritatevole magnanimità di stampo che definirei “quasi ambrosiano”, dispensano ad ogni puntura)). A tratti, nel concerto d’ali vibranti, c’è gloria anche per qualche sparuto pesce che con un ‘plop’ e una bolla rompe la superficie dello stagno fagocitando un insetto impegnato in un assolo.La brezza gioca ad essere vento poi desiste, riprende, e ancora si placa. La maglietta fredda a contatto con la pelle è una piccola persecuzione. L’inazione vince il fastidio è scelgo di lasciare le cose come stanno. Nel coperchio del cielo conto quattro nuvole bianche pascolanti al limitare dell’azzurra prateria. Avvertiranno anche loro la solitudine, in cotanta immensità?
Mi risulta naturale il confronto critico con il mio appartamento, una cella di condominio-alveare. Una manciata di metri quadri pittati dello stesso colore cereo della città di fuori. Finestre condannate a fissare eternamente la facciata del palazzo dirimpetto. E fuori l’abbaiare dei clacson e lo sferragliare del 16.
Le nuvole sono un poco più distanti, ora. Mi sento un inutile granello di polvere. Un inutile granello di polvere posato sul trasfigurarsi delle cose. Anche ieri notte mi sentivo così. Per questo sono scappato fin quassù. Cinque minuti fa credevo ingenuamente che la mia fosse una romantica e improbabile fuga da un mondo agonizzante. Ma questo mondo agonizzante me lo porto dentro. Tale dolorosa constatazione mi lascia un retrogusto amaro nel pensiero.
Non c’è riparo che valga, quando sei braccato da te stesso.
Guglie feriscono il cielo. Rocce dipingono fantasiosi arabeschi. Chiazze di neve s’accucciano all’ombra di monolitiche pareti. Limitar di boschi sfumano in ghiaioni inaccessibili. Con freddezza da notomista dimezzo un filone di pane. Rapido zigzagare di coltellino. Poi ingozzo il cadavere mollicoso di prosciutto crudo e mi preparo al fiero pasto.
Nel minuscolo stagno i girini disegnano sinusoidi con l’esile coda. Cotti da un implacabile sole allo zenit vanno a morire dov’è più fango che acqua. E nemmeno sanno d’essere esistiti.
Noi uomini abbiamo l’arroganza di dire “Io Sono”, “Noi Siamo”. Ma se il buon Dio (o chi per esso) ci avesse provvisto di coda, penso che l’agiteremmo in modo altrettanto stupido.
racconto di Enrico Gaffuri




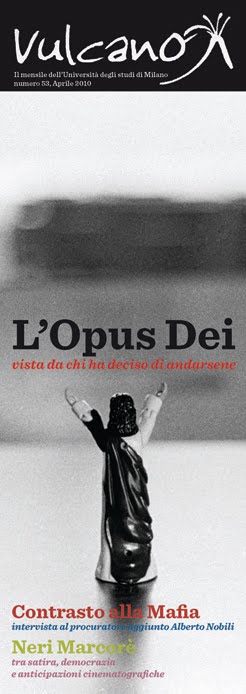















Nessun commento:
Posta un commento