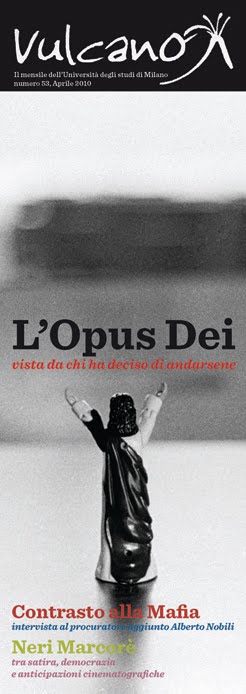E’ capitato tutto così. Un soffio di vite che in comune non avevano un bel niente. Di colpo legate, unite, una cosa sola.
-Avevo bucato. Con le gomme è sempre così. Le avevo bistrattate e forse dimenticate. Questa doveva proprio essere una loro vendetta.
-Nel fumo stantio del bar di paese, con ai muri la formazione dell’Inter 87’88 cercai solo di capire se ci fosse qualcuno e se quel qualcuno sarebbe stato in grado di aiutarmi o, meglio, tranquillizzarmi.
-Ero già entrato da parecchi secondi, almeno venti, quando sentii una voce. E forse solo allora mi scossi.
-Fu come svegliarsi. La luce filtrava con poca convinzione dalle finestre alle mie spalle, e la poca che arrivava al bancone illuminava pallide olive e salatini tristerelli.
-La voce mi fece sgranare gli occhi. E allora smisi di perdermi tra gli odori di bestemmie, bianchini e paginoni di Gazzetta. Davvero sembrava che nessuna legge antifumo fosse ancora giunta in quei luoghi.
-Sul bancone spuntavano posacenere colmi di cicche. Avevo gli occhi pieni di quel luogo. Forse li spalancai, credendo che altrimenti la voce non sarebbe mai potuta entrarci.
-Non risposi, né diedi cenno di intesa. Alla mia destra tra il fumo che si faceva più denso, indovinai la presenza di un’altra stanza.
-La cercai con strana convinzione. Notai che i miei passi non facevano alcun rumore. La cosa mi parve strana, perché il pavimento sembrava di legno.
-Eccola. Da subito trovai che la stanza avesse degli stucchi un po’ ridicoli. Almeno in alto, sul soffitto. Si intravedevano nonostante la nebbiolina. Le pareti, invece erano affrescate come oggi non si usa più. Quello che legava gli affreschi era il motivo del grappolo d’uva. Delle linee rosse, come fossero i nastrini che le bambine usano mettersi tra i capelli, collegavano i grappoli. Gli affreschi correvano su tutte le pareti della stanza e sembravano confluire in un punto che stava di fronte a me.
-Il camino attirava le linee, i grappoli e parte del mio sguardo. Io ero distratto dalle figure che si affollavano attorno ad un tavolino solitario. A lungo mi sembrò quasi che fossero disegnate.
-Quando mi avvicinai, capii quello che c’era da capire. Sul tavolo c’erano: un posacenere (al centro), una bottiglia di Fernet, una di Strega ed un’altra, senza etichetta.
-Sorrisi alle figure attorno al tavolo, e loro mi pregarono di accomodarmi accanto a loro. Continuavo a sorridere, senza curarmi dei miei occhi, di colpo lucidi.
- Il primo, alla mia destra, era robusto e rossissimo. Si vedevano le venine violacee tra gli occhi e le guance. I pochi capelli, bianchi, gli sparavano senza direzione sopra le orecchie. Il bicchierino che stringeva tra le dita tozze era sporco di Fernet sul fondo e scompariva nel suo pugno.
-Guardandomi, abbassò gli occhi, annegandoli in un sorriso amaro. Iniziò a parlarmi in dialetto. Io ero contento, perché lo capivo. Ma nel parlare sembrava che nemmeno avesse bisogno di muovere le labbra.
-Era preoccupato per il futuro, per la sconfitta definitiva dei suoi ideali. Aveva combattuto per una vita intera, e ora si ritrovava a dover ammettere di essere uno sconfitto.
-Il solo sentire certe cose, mi dava fastidio. Di discorsi pessimisti ne avevo sentiti fin troppi. Tuttavia capivo quanto questo vecchietto potesse soffrire. Sentii un’insanabile bisogno di trattenermi nell’accarezzare la sua pelle ruvida ma tolettata. Poi non le feci, ma forse cercai la sua mano. Volevo fargli coraggio. Partecipai col suo racconto al dolore per la sua casa data alle fiamme. Poi sentii di volergli solo un gran bene quando mi disse che anche lui aveva partecipato alla liberazione. Rimasi a guardare le sue mani gesticolare, senza riuscire a dire nulla, quando mi raccontò del suo amico Jonah, portato via e mai più ritornato.
-Fui invaso da dolcezza e leggerezza. Dalle macerie di una casa aveva salvato una ragazza. E su quelle macerie, nottetempo era tornato, e si era unito per sempre a lei.
-“Ho avuto anche io venti anni”
-Non seppi mostrargli quanto gli fossi grato.
-Di persone curiose ne ho viste davvero parecchie. Tuttavia, nelle occasioni in cui mi reputo una persona felice, so ancora stupirmi.
-La figura che si nascondeva dietro alla bottiglia di Strega iniziò a parlare presentandosi. “Mi chiamo Alda”, disse, “sono una persona molto anziana, perché ho più di 85 anni e fumare mi piace da morire”.
-Vestiva una camicetta a fiori, di quelle che io avevo visto sulla pelle di mia nonna e su qualche signora in estate. I capelli su quella testa canuta non avevano alcun senso, ma aveva degli occhi pieni di livore.
-Le sue parole erano dense e piene di ansia. Capii che aveva voglia di essere ascoltata. Mi ci misi di impegno. Mi accorsi in fretta che le sue parole danzavano, come farfalle coloratissime. Uscivano svolazzanti e senza direzione tra il fumo delle sigarette che si accendeva una dopo l’altra.
-Non saprei ripetere una singola cosa che mi disse. Ma la sua bocca sgranata e la sua voce ruvida mi facevano soffrire e avere rispetto insieme.
-La bottiglia senza etichetta si trovava a pochi centimetri dalla mano incerta dell’unica persona che non mi aveva ancora rivolto parola.
-Aveva due occhi enormi. Bagnati, umidi, inespressivi, impauriti. La mano era semichiusa.
-Subito pensai alla straordinaria bellezza che questa donna aveva dovuto possedere da giovane. La vedevo nella sua figura incerta ma elegante sbattere le palpebre e sorridere nutrendo le sue rughe.
-Mi guardava spaesata. Vedevo che le parole volevano uscire da quella bocca tesa ma proprio non ci riuscivano. Dannatamente a disagio, dissi, un po’ guardando lei e un po’ le altre due figure: “Sapete, ho bucato una gomma, ma mi riesce difficile tirar fuori anche solo un ragno da quel buco”.
-Nemmeno un sorriso. Nemmeno un gesto di comprensione.
-La splendida nonnina muta, senza dire nulla, riversò nelle mille rughe del suo viso tutte le lacrime di cui era capace.
-Il vecchietto col bicchierino sporco di Fernet mi mise una mano sulla spalla, (sentii che era una mano davvero stanca), e mi indicò un giradischi dalla parte opposta della stanza.
-Mi alzai deciso. Strinsi più mani possibile. Tutti cercavano di baciarmi, come fossi loro nipote.
-Non avevo mai visto un giradischi simile. Forse il nonnino aveva parlato di grammofono. Incerto, girai il disco e lessi sull’etichetta al centro del vinile: Glenn Miller Orchestra “Glenn’s Jive”.
-Posizionai il diamante dove l’incisione avevano inizio. Il disco, friggendo, mi diede coraggio.
-Prima fu buio. Poi il camino si mise a crepitare squarciando la tenebra. I grappoli d’uva, che non sembravano nemmeno più solo dipinti, presero un colore nuovo. E di colpo la stanza fu piena di gente.
-Ragazze giovani ed eleganti mi sfioravano. Ballavano. E con loro cavalieri in gessato. I miei jeans erano la cosa più stridente potessi indossare.
-Intravidi il tavolo. Sedeva solo la donna con la sigaretta. Era come un corpo altro. La musica non la interessava affatto. D’un tratto scriveva convulsamente su un tovagliolo.
-Poi, tra i frack e le scarpe di lucido vidi lui. Era il più scatenato. Ballava con una donna. Sembravano danzare a memoria, come se nulla dovesse essere aggiunto. Lei sorrideva, e lui, con i capelli pieni di brillantina faceva lo stesso. Ebbi il flash della sua mano sulla mia spalla, pochi istanti prima e fui confuso.
-Le mie All Star azzurre e arancione si accendevano come torce con il luccichio del camino.
-Ero buffo e ridicolo come un clown. Avevo i piedi grandissimi rispetto agli altri. Chi ballava me li pestava senza cura. Avrei preferito essere scalzo.
-Trovai una sedia. Levai le scarpe. Quando la vidi.
-Era proprio bella come l’avevo immaginata. Giovane. Gli occhi uguali. Pieni di tristezza e spessi di lacrime.
-Così, scalzo, andai sicuro da lei. Le toccai la mano. Abbassò gli occhi e si toccò la veste, che –ricordo- era bianchissima.
-Poi si lasciò cadere. La presi tra le braccia sfiorandole i seni. Cercai i suoi occhi.
-Candidi e dolci.
-Presi il suo viso tra le braccia. Provai il sentimento più naturale e privo di malizia. Desiderai la sua pelle giovane. Avvicinai le labbra al suo collo e lo sentii freddo.
-Non so raccontare con queste parole cosa si provi nel sentire una persona morire tra le proprie braccia. Di certo non posso dire sia una cosa bella. Nemmeno una cosa brutta. E’ una cosa che magari ti fa piangere.
-Quando piangi, e le lacrime seguono le linee del tuo viso, fino a sfiorarti le labbra. Allora capisci almeno di che gusto sia il pianto.
-La sofferenza, il dolore, il pianto possono nascere così. Da una ruota bucata, o da un richiamo non ascoltato. Per chi scrive, per chi fotografa, per chi suona il dramma è proprio questo: pensare ad altro.
-E per pensare ad altro non servono venti anni. Non ne servono ottanta. Servono orecchie e un paio di mani più o meno ben fatte.
racconto di Davide Zucchi
 Lo scorso 22 ottobre è ufficialmente uscito il secondo album della band romagnola dei Koinè sempre pubblicato con la linea low-cost di mini-cd prodotta dall’Alkatraz scrl. Sebbene questo loro secondo disco si presenti allo stesso modo del primo (Senza tranquillità) ossia tre canzoni più un video, i Koinè centrano un’altra volta il bersaglio, producendo un mini-cd di tutto rispetto. Con Sospeso la band dimostra di essere riuscita a crescere artisticamente componendo dei testi più adulti e conferma l’attitudine verso sonorità a tratti più cupe con riff graffianti di chitarra come nell’opener “Rivoluzione”, o con giri di basso accattivanti e facilmente orecchiabili che catturano l’attenzione in “Solo una sensazione”. Con la title track “Sospeso” ritroviamo invece la vena pop del gruppo con un singolo di facile ascolto tipicamente radiofonico anche se attraversato verso la fine – seppur per pochi secondi - da elementi tipici dell’alternative pop-rock. A dispetto del precedente però, questo singolo sembra purtroppo più debole, e soprattutto a metà canzone si sente come una mancanza di mordente. Fortunatamente però questo non intacca eccessivamente la qualità complessiva dell’album, che rimane comunque un disco tutto da ascoltare. Un gruppo sicuramente da tenere d’occhio nel futuro, e che continua a proporre un rock alternativo fresco e dinamico.
Lo scorso 22 ottobre è ufficialmente uscito il secondo album della band romagnola dei Koinè sempre pubblicato con la linea low-cost di mini-cd prodotta dall’Alkatraz scrl. Sebbene questo loro secondo disco si presenti allo stesso modo del primo (Senza tranquillità) ossia tre canzoni più un video, i Koinè centrano un’altra volta il bersaglio, producendo un mini-cd di tutto rispetto. Con Sospeso la band dimostra di essere riuscita a crescere artisticamente componendo dei testi più adulti e conferma l’attitudine verso sonorità a tratti più cupe con riff graffianti di chitarra come nell’opener “Rivoluzione”, o con giri di basso accattivanti e facilmente orecchiabili che catturano l’attenzione in “Solo una sensazione”. Con la title track “Sospeso” ritroviamo invece la vena pop del gruppo con un singolo di facile ascolto tipicamente radiofonico anche se attraversato verso la fine – seppur per pochi secondi - da elementi tipici dell’alternative pop-rock. A dispetto del precedente però, questo singolo sembra purtroppo più debole, e soprattutto a metà canzone si sente come una mancanza di mordente. Fortunatamente però questo non intacca eccessivamente la qualità complessiva dell’album, che rimane comunque un disco tutto da ascoltare. Un gruppo sicuramente da tenere d’occhio nel futuro, e che continua a proporre un rock alternativo fresco e dinamico.