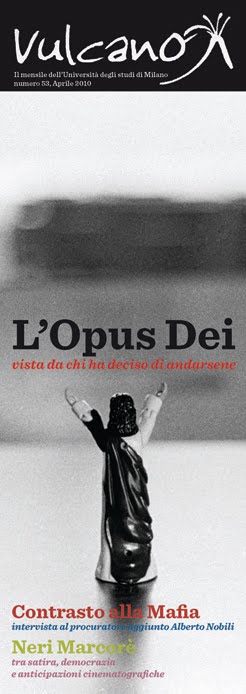Cominciamo da una domanda semplice: come nasce la televisione italiana?
Cominciamo da una domanda semplice: come nasce la televisione italiana?
La televisione italiana nasce nel '54, affidata alla Democrazia Cristiana.Fino alla fine degli anni ‘70 è stata una televisione fortemente pedagogica, ma anche capace di aprire al meglio del Paese, ai grandi intellettuali come
Eco, Vattimo, Guglielmi, Furio Colombo. In seguito si capisce che la gestione illuminata della DC non può essere l'unica garanzia di pluralismo, allora - e siamo alla metà degli anni ‘70 - nasce la cosiddetta Riforma, che coincide con la fine della direzione Bernabei. La RAI viene tripartita: alla DC va il primo canale, al mondo laico-socialista il secondo e ai comunisti la tv regionale.
Poi, negli anni '80, arriva questo strano signore dall'edilizia che si chiama Silvio Berlusconi. E lui è l'unico che intuisce una cosa fondamentale: per fare la fortuna della tv commerciale non devi più decidere quali spazi dare e come impiegarli, ma dare l’opportunità a forze piccole, imprenditoriali di partecipare al banchetto televisivo.
Comunemente si crede che l'arrivo di questa nuova televisione, culturalmente peggiore della precedente, abbia anche influito negativamente sulle persone, rimbecillendole…
C’è un modo molto banalizzante di affrontare il problema, ma se lo affrontiamo in termini antropologici è molto serio. In una società come la nostra, dove le cosiddette agenzie educative - la Chiesa, la scuola, la famiglia, i partiti, il mondo operaio - stanno perdendo la loro forza formativa, la televisione ha assunto un peso evidente in termini di modelli antropologici. Questo è un problema vero, perché gran parte della popolazione italiana fruisce in maniera pesante proprio della televisione, a discapito degli altri media.
La televisione commerciale, per sua natura, non si è mai assunta problemi di tipo pedagogico o educativo, ma solo il compito di massimizzare gli utili. In questo Mediaset è stata uno dei più clamorosi esempi europei. Però, laddove c'è un canone pagato dal cittadino, la RAI avrebbe dovuto mantenere il proprio lavoro di servizio pubblico, ma con la corsa alla massimizzazione degli ascolti si sta dimenticando cosa voglia dire fare servizio pubblico.
Quale può essere la soluzione?
Sto diventando sempre più scettico a riguardo. Se lei mi avesse fatto questa domanda cinque anni fa, le avrei risposto: sì, bisogna fare, costruire... Dentro la RAI c'è ancora una bella fetta di persone che è cresciuta dentro un grande progetto culturale, e ne ha memoria, ce l'ha nel suo dna, ma non è questa la RAI che ha figliato. E man mano chi ha costruito l’identità forte della prima RAI se ne andrà.
Ormai c'è una classe dirigente che in gran parte non sa come si fa il servizio pubblico, questa è la verità e questo la sta facendo morire.
A proposito di pluralismo, anche la RAI oggi ha diversi canali, oltre a quelli istituzionali. Chi fa televisione in questo momento, chi ne è il vero artefice, chi sono quelli che regolano i palinsesti, scrivono i programmi, eccetera?
Ormai la nostra è una televisione che va per forti personalità. Un esempio: Maria De Filippi. E' il 50% di Canale 5, e lo è in quanto De Filippi, grazie alla sua capacità di fare ascolti, di fare corpo con il Paese, di interpretare un certo tipo di classe giovane. Parallelamente a una De Filipp

i, può corrispondere Carlo Conti. Paradossalmente Conti, che sembrerebbe apparentemente "una cosa priva di personalità", in realtà dà un cifra forte alla RAI in questo momento, che è ahimè una cifra di revival, di memoria, di ricordo.
Non c'è quindi un'idea programmatica.
No. Cominciò a sperimentarlo Berlusconi: direttori di rete, quindi non gestori di una linea editoriale, ma uomini di marketing, che riuscivano a soddisfare il target di pubblico. Questo modello si è trasferito anche dentro la RAI. Vi faccio un esempio molto significativo. Dentro la RAI si sta diffondendo sempre più l'idea di affidare le reti ai giornalisti, che è un non senso: il giornalista non sa di palinsesto, il giornalista ha un altro tipo di formazione. Eppure pensiamo a Del Noce, Mazza, Ruffini, Di Bella. Le due reti principali -RAI 1 e RAI 3- sono dirette ormai da almeno quindici anni da giornalisti. Prima il cursus per diventare direttore di rete era diverso.
Passiamo a Tv Talk. Lei ha una redazione giovane, sono tutti universitari, giusto? Cosa vede in questi ragazzi, nati con la televisione, rispetto per esempio ai docenti presenti in trasmissione? Nota una differenza anche nell'interpretazione delle cose?
Eh sì, perché tutta la storia di cui vi ho parlato prima, i ragazzi di oggi non la conoscono. Io sono nato teledipendente fin da bambino, ma teledipendente RAI, mentre i ragazzi sono cresciuti dentro le reti Mediaset. Ma c’è anche un altro problema. Oggi noi stiamo idolatrando, in termini di afflusso, le Facoltà di Scienze della Comunicazione, che sono il vero boom degli ultimi quindici anni. Stiamo sfornando, e lo stesso vale per chi studia giornalismo, tonnellate di laureati che non sapremo come impiegare.
Secondo lei la televisione è ancora un mezzo rivoluzionario, ha ancora la capacità di cambiare le cose che aveva quando è nata? Oppure lo è sempre meno, rispetto a internet, per esempio.
Io ho l'impressione che sia destinata ad appannarsi un po'. Quello che mi colpisce è che si sta affermando un modello di rito televisivo che non ha più al centro l'appuntamento televisivo. Tutto si può seguire in differita sul sito RAI, al di là del giorno di messa in onda. E questo rivoluzionerà i palinsesti.
Secondo me l’impero della tv generalista finirà fra una decina d’anni, forse meno. La pubblicità andrà da altre parti, come già sta succedendo: sta scendendo vistosamente dai giornali, poi scenderà dalla televisione generalista, e quest’ultima si ridurrà di peso ed entrerà in un mezzo come internet, spezzettata e sparsa. Però c'è ancora una cosa da risolvere: il modello di business. Finora dentro la tv generalista era chiaro come si poteva sviluppare il rapporto fra pubblicità e canone, come si poteva rientrare nei costi. Con internet il modello è ancora acerbo. Tutti stanno correndo verso la tv a pagamento, hanno capito che il vero business su cui lavorare, adesso che la pubblicità è in crisi, è un prodotto su misura per lo spettatore che è disposto a pagare. E sarà sempre più così.
Come sarà la televisione del futuro?
Come sarà francamente non lo so. Io vedo che il futuro è un gran casino, sopratutto se non si risolvono i modelli di business, cioè la redditività vera, il lavoro. Per adesso tutto quello che noi vediamo è prodotto da un modello di business precedente -o pubblicità o canone-. Ci si basa ancora sui prodotti generalisti, anche se magari vengono guardati su YouTube e non solo attraverso la canonica messa in onda. Vediamo Un medico in famiglia, Checco Zalone, Susan Boyle, quei pezzi di televisione generalista che sono pagati ancora da un vecchio modello di business. Ma se questo viene meno?
Qualcuno Zalone lo deve pagare, qualcuno deve pagare i cameraman, lo scenario, il teatro. Stessa cosa sta per succede con la musica: chi li paga i dischi alla fine? Scarichiamo tutti gratuitamente – meraviglioso - ma alla fine, quando si devono tirar fuori quelle migliaia di euro per andare in sala di incisione, chi li caccia questi soldi?

L'idea che bisogna pagare per avere queste cose oggi è quasi un insulto, ma non può durare all'infinito, perché altrimenti finiranno i musicisti. Il musicista deve mangiare. Qui si tratta di capire chi inventerà nuovi modelli. Insomma sarà un nuovo mondo, vedremo che mondo sarà.
Giuseppe Argentieri e Giuditta Grechi
 Nell’estate del ’94, un Karl Raimund Popper novantaduenne e fisicamente molto debilitato -morirà a settembre dello stesso anno- non rinunciava ad affermare con decisione i propri timori riguardo alle potenzialità negative del mezzo televisivo. Il saggio cui Popper dedica le sue riflessioni, dall’eloquente titolo Cattiva Maestra Televisione, è stato molto apprezzato a livello internazionale, ma altrettanto criticato e discusso, non senza qualche sfiducia nelle capacità di un vecchio filosofo, nato agli albori del Novecento, di capire un mezzo ancora così giovane come la televisione, tutto proiettato nel secolo successivo. Ma rilette oggi, a distanza di quindici anni, le sue riflessioni e i suoi moniti non sembrano poi così antiquati e privi di fondamento. Le sue maggiori preoccupazioni sono rivolte alla forza con cui la legge della corsa all’audience riesce a plasmare i programmi televisivi trascinandoli sempre più verso un fondo privo di qualità. Violenza, sesso e sensazionalismo sarebbero così le spezie di un piatto mediatico pressoché insipido e cucinato con crescente incompetenza.
Nell’estate del ’94, un Karl Raimund Popper novantaduenne e fisicamente molto debilitato -morirà a settembre dello stesso anno- non rinunciava ad affermare con decisione i propri timori riguardo alle potenzialità negative del mezzo televisivo. Il saggio cui Popper dedica le sue riflessioni, dall’eloquente titolo Cattiva Maestra Televisione, è stato molto apprezzato a livello internazionale, ma altrettanto criticato e discusso, non senza qualche sfiducia nelle capacità di un vecchio filosofo, nato agli albori del Novecento, di capire un mezzo ancora così giovane come la televisione, tutto proiettato nel secolo successivo. Ma rilette oggi, a distanza di quindici anni, le sue riflessioni e i suoi moniti non sembrano poi così antiquati e privi di fondamento. Le sue maggiori preoccupazioni sono rivolte alla forza con cui la legge della corsa all’audience riesce a plasmare i programmi televisivi trascinandoli sempre più verso un fondo privo di qualità. Violenza, sesso e sensazionalismo sarebbero così le spezie di un piatto mediatico pressoché insipido e cucinato con crescente incompetenza. vo sottoporrebbe l’uomo. In Homo Videns,pubblicato per la prima volta tre anni dopo il saggio popperiano, Giovanni Sartori sostiene senza indugio l’impoverimento dell’apparato cognitivo umano ad opera della televisione. Il predominio del visibile sull’intellegibile porterebbe lo spettatore al pigro automatismo del vedere senza capire, del fruire passivamente di una sequenza di immagini senza che vi sia la necessità di intervento della capacità astrattiva e dell’immaginazione, che sono invece alla base dello sviluppo del pensiero dell’uomo, della sua evoluzione in quanto specie. Sartori non dimentica poi il ruolo, sempre in questa direzione, del fenomeno internet, che porterà l’homo digitalis a rimpiazzare il suo recente antenato homo prensilis. Non si tratta solo di una modificazione genetica, la televisione ha trasformato radicalmente le condizioni della nostra società: l’opinione pubblica è telediretta, nasce e dipende dallo schermo. La politica è diventata videopolitica, e i politici non possono fare a meno di diventare immagini in movimento e di sfruttare l’efficacia invasiva dell’opinion leadering televisiva. È ancora Popper d’altronde a ipotizzare che “un nuovo Hitler avrebbe, con la televisione, un potere infinito”.
vo sottoporrebbe l’uomo. In Homo Videns,pubblicato per la prima volta tre anni dopo il saggio popperiano, Giovanni Sartori sostiene senza indugio l’impoverimento dell’apparato cognitivo umano ad opera della televisione. Il predominio del visibile sull’intellegibile porterebbe lo spettatore al pigro automatismo del vedere senza capire, del fruire passivamente di una sequenza di immagini senza che vi sia la necessità di intervento della capacità astrattiva e dell’immaginazione, che sono invece alla base dello sviluppo del pensiero dell’uomo, della sua evoluzione in quanto specie. Sartori non dimentica poi il ruolo, sempre in questa direzione, del fenomeno internet, che porterà l’homo digitalis a rimpiazzare il suo recente antenato homo prensilis. Non si tratta solo di una modificazione genetica, la televisione ha trasformato radicalmente le condizioni della nostra società: l’opinione pubblica è telediretta, nasce e dipende dallo schermo. La politica è diventata videopolitica, e i politici non possono fare a meno di diventare immagini in movimento e di sfruttare l’efficacia invasiva dell’opinion leadering televisiva. È ancora Popper d’altronde a ipotizzare che “un nuovo Hitler avrebbe, con la televisione, un potere infinito”. 







 Un foro di proiettile all’altezza del polmone sinistro, il volto completamente tumefatto. Ha le spalle piccole Bonnot, e guardando la fotografia del suo cadavere, a torso nudo, disteso su una tavola di legno, sembra quasi un ragazzo. Il giorno della sua morte era presente un intero esercito. Reparti della gendarmeria, carabinieri, vigili del fuoco, cittadini armatisi volontariamente per l’occasione, curiosi, cronisti locali e nazionali. C’era perfino una macchina da presa, agli esordi nel mondo della cronaca nera. Il giorno della sua morte, Jules Bonnot era l’uomo più famoso di Francia. Un anarchico, un assassino, un criminale, uno di quelli che dalla storia sono stati traditi, e che hanno cercato per tutta la vita la propria vendetta.
Un foro di proiettile all’altezza del polmone sinistro, il volto completamente tumefatto. Ha le spalle piccole Bonnot, e guardando la fotografia del suo cadavere, a torso nudo, disteso su una tavola di legno, sembra quasi un ragazzo. Il giorno della sua morte era presente un intero esercito. Reparti della gendarmeria, carabinieri, vigili del fuoco, cittadini armatisi volontariamente per l’occasione, curiosi, cronisti locali e nazionali. C’era perfino una macchina da presa, agli esordi nel mondo della cronaca nera. Il giorno della sua morte, Jules Bonnot era l’uomo più famoso di Francia. Un anarchico, un assassino, un criminale, uno di quelli che dalla storia sono stati traditi, e che hanno cercato per tutta la vita la propria vendetta.