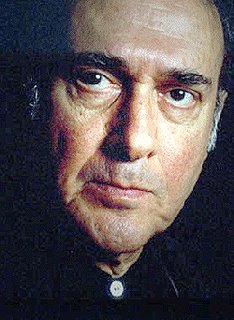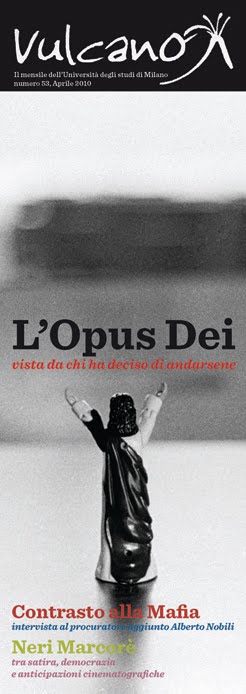“Conta più la strada della meta. Conta più il vento della valigia.”
Danilo Manera insegna letteratura spagnola nella nostra università. Da sempre appassionato di viaggi, nella sua vita ha viaggiato tantissimo, sia fisicamente che attraverso la letteratura, l’attività giornalistica e di traduttore, la passione per le altre lingue e culture. L’abbiamo contattato per discutere con lui del significato del Viaggio e dei retroscena dei suoi viaggi; in particolar modo della “spedizione” da lui compiuta nella zona del Vaupes, remota ed “incontaminata” regione amazzonica della Colombia.
Per cominciare, la domanda di rito: come è nato in lei l’interesse per il viaggio ed in particolar modo la passione per la Spagna e l’America Latina?
Sono nato nelle Langhe, in una cittadina della provincia piemontese.  Contrariamente alla fama di immobilismo che ha, è terra di emigranti e scrittori, un posto limitato da cui partire, smentendo l’orizzonte di colline, anche per poi gustarsi i ritorni. In un primo tempo, sull’onda di Pavese e Fenoglio, rivolsi il mio interesse all’area anglofona, e contemporaneamente alla Francia, poi all’università di Pisa scelsi le lingue slave e infine m’appassionai allo spagnolo. Durante gli studi approfittai di tutte le borse di studio che mi venivano a tiro. Poi mi toccarono quasi due anni di servizio civile come obiettore di coscienza e nelle lunghe sere di quella pausa forzata, cominciai a sognare viaggi più lunghi, più in profondità, con un tesoro di storie e parole da riportare a casa. Presi così, appena possibile, la rotta dei tramonti, prima verso la Spagna, poi verso il Sudamerica.
Contrariamente alla fama di immobilismo che ha, è terra di emigranti e scrittori, un posto limitato da cui partire, smentendo l’orizzonte di colline, anche per poi gustarsi i ritorni. In un primo tempo, sull’onda di Pavese e Fenoglio, rivolsi il mio interesse all’area anglofona, e contemporaneamente alla Francia, poi all’università di Pisa scelsi le lingue slave e infine m’appassionai allo spagnolo. Durante gli studi approfittai di tutte le borse di studio che mi venivano a tiro. Poi mi toccarono quasi due anni di servizio civile come obiettore di coscienza e nelle lunghe sere di quella pausa forzata, cominciai a sognare viaggi più lunghi, più in profondità, con un tesoro di storie e parole da riportare a casa. Presi così, appena possibile, la rotta dei tramonti, prima verso la Spagna, poi verso il Sudamerica.
Lei si è occupato molto - soprattutto attraverso la traduzione di testi di narrativa – dell’area caraibica. Un'area che purtroppo nell’immaginario collettivo è quasi esclusivamente legata ad un fuorviante stereotipo vacanziero ma che, credo, abbia una ricchezza culturale ben più ampia. Che cosa ci può dire a riguardo?
I Caraibi sono connessi con l’idea di paradiso, un luogo mite e dolce, precedente alle morali e alle ideologie, un luogo aperto dove infinite cose sono ancora possibili.
Purtroppo, l’idea di paradiso che rimane a tanti è quella misera e cartolinesca delle due settimane in spiaggia. Caraibi significa ballo e meticciato: una capacità di suonare e di mescolarsi. Lì il crogiolo etnico-culturale ha creato ritmi, pitture e scritture straordinarie. Io non mi stanco di proporre antologie di autori caraibici. Da ultimo L’isola d’acqua, un libro dedicato ad Haiti, al quale ha collaborato Marco Modenesi della nostra università e che accompagna il documentario di J. Demme The Agronomist, e due raccolte tradotte da allievi dei miei corsi, Onde, farfalle e aroma di caffè. Storie di donne dominicane e Fantasmario di Marcio Veloz Maggiolo.
Lei ha scritto molto su Cuba, collaborando anche a guide e vari libri fotografici dedicate a quell’isola. Cosa pensa delle recenti polemiche sulla situazione politica cubana, innescate circa un anno fa dalla condanna a morte di alcuni dissidenti e riaccesesi da qualche settimana a seguito dell’espulsione di alcuni giornalisti italiani sbarcati sull’isola in occasione di un congresso degli oppositori al governo di Castro?
Ho scritto ampiamente sul tema, che non è riassumibile. Rimando soprattutto al n.4 del 2004 della rivista di geopolitica «Limes». Ho grande rispetto per le sofferenze del popolo cubano, vittima dell’embargo statunitense. E un amore profondo per la cultura e i talenti dei cubani, il loro modo inconfondibile e umanissimo di stare al mondo. Sono per il dialogo e la solidarietà. Ma non confondo Cuba con Castro. I castristi sono chiusi a ogni verifica o divergenza, demonizzano l’interlocutore con rituali da caserma, negano ogni cittadinanza alla diaspora. Invece, per il movimento civile, utopico e pacifista di cui mi sento parte i diritti umani, la libertà d’espressione e associazione, la partecipazione pluralista, l’ecologia, la valorizzazione delle diversità, il rispetto delle minoranze sono presupposti irrinunciabili. L’odio e la repressione non sono una risposta. Nemmeno l’inamovibilità dei capi. Certo, la situazione è difficile, ma spero che si smuova e che i cubani sappiano sviluppare la loro alternativa al neoliberismo in modo davvero libero.
Il viaggio più bello che lei ci ha raccontato credo sia quello svolto nella zona dello Vaupés in Colombia, da cui è nato il libro Yuruparí. I flauti dell'anaconda celeste. Come è nata l’idea di riprendere una spedizione di un esploratore ottocentesco - Ermanno Stradelli - nell¹Amazzonia colombiana e ripercorrerne il tragitto?
Le spinte sono state tante. Ne citerò due. La versione più elaborata della leggenda di fondazione dei popoli del nordovest amazzonico si conserva in italiano grazie alla sensibilità di Stradelli, che era anche un linguista d’eccezione: a lui si devono grammatica e dizionario della lingua franca di quei territori. Stradelli era affascinato dal diverso e disposto a capirlo. Inoltre, nei giochi di bambini, io e mio fratello stavamo sempre dalla parte degli indiani contro i cowboys. Una volta nella vita, ci tenevamo a vivere un po’ con una tribù indigena. È stato emozionante e complesso, ma ha richiesto una lunghissima preparazione.
Cosa le ha lasciato quell’esperienza a contatto con le usanze, le leggende, i miti di popolazioni lontanissime dallo stile di vita occidentale?
Tantissime cose. Relativismo di fronte al “progresso” e alle “verità”, pena per quel che perdiamo e togliamo alle generazioni future con l’attuale omologazione al ribasso, spianata oltretutto sui modelli più sciocchi. Gratitudine per la disponibilità degli indigeni tucano e dei colombiani. Un’amaca appesa in una stanza della mia casa milanese. Quell’aculeo di cerbottana della nostalgia che si sente per ogni cosa lontana che un giorno è stata tua. Qui più forte perché dal Vaupés è meglio che tutti i bianchi stiano lontani, anch’io. E l’impegno a far sì che la scrittura sia una canoa che scivola su un fiume, che a sua volta è l’anima disciolta di una canoa. Gli sciamani tucano dicono che l’anaconda ancestrale trasportò le genti nel suo ventre in forma di pesci e ancora adesso gli uomini nascono dall’acqua profonda delle donne in cui c’è la stessa geografia di fiumi e cieli e sogni che poi troveranno fuori, dove splende l’anaconda celeste come un latteo sentiero luminoso.
Quale legame pensa ci sia tra letteratura e viaggio? Crede sia possibile in qualche modo viaggiare attraverso la letteratura?
Caspita! I libri sono il miglior mezzo di trasporto che c’è. Ho sempre pensato alla biblioteche come porti da cui salpare. Ho sempre viaggiato sulla scorta di letture e i viaggi hanno a loro volta prodotto scritti. Senza contare che ci sono terre che esistono solo nella memoria e nella fantasia, a cui si va soltanto grazie alla letteratura. L’osmosi è antichissima, perché la letteratura ha bisogno di spaesamento e di moto: da Ulisse a Don Chisciotte, da Dante a Ibn Batuta, da Marco Polo ai cantastorie, dagli scienziati illuministi ai vagabondi on the road.
Centrale in tutta la sua produzione giornalistica e letteraria sul viaggio, mi sembra, personalmente, il concetto di “rispetto” . Rispetto per i luoghi visitati e le genti incontrate. Pino Cacucci, un altro grande esploratore dei paesi latinoamericani, ha scritto che «il contatto con l’altro a qualsiasi latitudine [deve iniziare] con un gesto di resa incondizionata, la rinuncia ai propri schemi e abitudini». Qual è la sua opinione a proposito?
Sono d’accordo con Cacucci. L’incontro con l’alterità è un’occasione unica. Guai a perderla perché si ha in tasca un copione e foschia negli occhi. Si viaggia per cambiarsi, non per confermarsi. Già il viaggiatore Montaigne diceva che sapeva da cosa fuggiva, ma non cosa cercava. E che l’incessante diversità di vite incontrate sul cammino era la miglior formazione per l’anima. Poi ci vuole anche molta, spregiudicata curiosità.
Sintetizzando, qual è il consiglio principale che darebbe a chiunque sia appresti ad un viaggio che non voglia solo essere un’evasione o una vacanza, ma piuttosto un’esperienza conoscitiva consapevole e intelligente?
Conta più la strada della meta. Conta più il vento della valigia. Contano più i passi o i compagni di viaggio degli orari o degli acquisti. Non c’è un manuale, ma una disposizione a trovare il proprio modo di camminare. Un giorno lo si riconosce in un ciottolo, un riflesso di luce, un sorriso, una nenia, una foglia, un silenzio, una vicenda letta o raccontata in forma inattesa. Allora tempo e spazio coincidono e si sente che la vita è, machadianamente, tracciare scie sul mare.
A cura di Francesco Zurlo
Chi è Danilo Manera?
Danilo Manera (Alba 1957) insegna Letteratura spagnola contemporanea all'Università degli Studi di Milano. Narratore, traduttore, critico letterario e giornalista di viaggio, ha collaborato ai quotidiani «L’Unità» e «Il Manifesto» e alle le riviste «MicroMega» «Avvenimenti» e «Limes». Attualmente dirige la rivista «Crocevia». Ha curato la traduzione italiana di parecchi importanti scrittori spagnoli nonché antologie di autori baschi, della Galizia e delle Canarie. Si è occupato molto anche di letterature slave. Ultimamente si è dedicato soprattutto dell’area caraibica, curando diverse antologie di scrittori cubani (ricordiamo perlomeno A labbra nude. Racconti dall’ultima Cuba, Vedi Cuba e poi muori,) e domenicani (I cactus non temono il vento). Per quanto riguarda il tema del viaggio ricordiamo, oltre a Yuruparí. I flauti dell’anaconda celeste, la partecipazione a diversi speciali di «Tuttoturismo» e di «Meridiani» sui paesi carabici e ad alcune guide turistiche su Cuba.
 Una Chiesa, quella latinoamericana, complessa e a dir poco eterogenea al suo interno.Da un lato ci sono vescovi come il cardinale Pio Laghi, oggi prefetto del dicastero Vaticano all’Educazione Cattolica: nunzio apostolico in Argentina durante gli anni della dittatura, amico intimo dei generali, conosceva perfettamente e tollerava i rapimenti e le uccisioni di oppositori politici. Per capire il personaggio basterà citare una sua omelia del giugno ’76: “il Paese ha un'ideologia tradizionale, e quando qualcuno pretende di imporre idee diverse ed estranee,
Una Chiesa, quella latinoamericana, complessa e a dir poco eterogenea al suo interno.Da un lato ci sono vescovi come il cardinale Pio Laghi, oggi prefetto del dicastero Vaticano all’Educazione Cattolica: nunzio apostolico in Argentina durante gli anni della dittatura, amico intimo dei generali, conosceva perfettamente e tollerava i rapimenti e le uccisioni di oppositori politici. Per capire il personaggio basterà citare una sua omelia del giugno ’76: “il Paese ha un'ideologia tradizionale, e quando qualcuno pretende di imporre idee diverse ed estranee,