 Anafi. Poche miglia marine in line d’aria da Santorini. Nei giorni limpidi la si riesce anche a scorgere, nell’azzurro dell’egeo, dalla Caldera di Santorini. Santorini centro del turismo organizzato, fulcro delle Cicladi. Isola connessa da decine e decine di traghetti che dal Pireo o dalle altre cicladi rigurgitano turisti a getto continuo sulle spiaggie di Thira.
Anafi. Poche miglia marine in line d’aria da Santorini. Nei giorni limpidi la si riesce anche a scorgere, nell’azzurro dell’egeo, dalla Caldera di Santorini. Santorini centro del turismo organizzato, fulcro delle Cicladi. Isola connessa da decine e decine di traghetti che dal Pireo o dalle altre cicladi rigurgitano turisti a getto continuo sulle spiaggie di Thira.Ad Anafi invece ci arrivano solo due traghetti alla settimana. O almeno dovrebbero, dal momento che - dice la Lonely Planet - le navi per questa piccola sfuggente isola hanno orari incerti e inaffidabili. Quando ci andai io, un anno fa, le navi attraccavano al suo piccolo porto di Agios Nikolaos, solo il mercoledì e il sabato. La permanenza minima sull’isola era quindi di quattro giorni. Ricordo il traghetto che sobbalzando su un mare poco piacevolmente inquieto, liberatosi dalli sciami di ragazzini italiani o tedeschi diretti in isole ben più note e mondane, viaggiava lento verso questo scoglio perduto in mezzo all’Egeo. A bordo erano rimasti solo uno sparuto gruppo di viaggiatori curiosi e i rifornimenti per questa isola sperduta.
Già la prima impressione, arrivando, fu quella di un luogo deserto, piacevolmente lontano da ogni forma di turismo organizzato. Un piccolo porticciolo, le reti gialle dei pescatori distese sul molo, un piccolo spaccio alimentare, poche case, una corriera che inerpicandosi per una strada tortuosa portava alla Hora, il capoluogo (o meglio l’unico centro abitato di rilievo dell’isola).
Rimandai al giorno dopo la visita alla cittadina, e invece, cercando un luogo per dormire, scoprì che l’unica opportunità, oltre ad una serie di domatie ormai da tempo già affittate ad altri turisti, era l’accampamento su Livadi Beach, la prima delle spiagge dell’isola. Una piccola meravigliosa spiaggetta orlata di palme, a cui si giungeva attraverso un minuscolo sentiero in costa, inerpicandosi tra piccole casette in affitto e taverne che emanavano profumo di souvlaki o pesce fresco.
La sera andammo a mangiare in una di queste taverne, sorta di locale terrazzato con vista sul mare. Sul tavolo il menù era poco più che un soprammobile, redatto chissà quanto tempo prima. L’unico modo per sapere quello che Ileni, la padrona del locale, aveva preparato quella sera, era farsi accompagnare per mano da lei in cucina, in mezzo a pentoloni odoranti di briam, e taglieri con gli avanzi di pesce liscato. Un donnone imponente, che parlava in greco stretto, infilando solo qua e là i nomi in inglese delle vivande, pronunciandoli con un suo strano accento cicladico, quasi più indecifrabile del greco stesso.
Quella sera chiaccherendo con Artemis, la figlia della proprietaria - l’unica che parlasse inglese in tutta la taverna- e con altri avventori italiani, scoprì molte cose sull’isola. Che d’inverno era abitata da solo 250 abitanti. Che ogni estate - fatta eccezione per i viaggiatori curiosi come me - sull’isola si vedevano sempre le stesse facce, giunte a conoscenza di quell’angolo remoto del Mediterraneo solo attraverso improbabili passaparola. Mi raccontò anche che i campeggiatori “selvaggi” di Livadi Beach avevano instaurato un buon rapporto con la gente locale; la stessa gente che invece mal sopportava la selva di fricchettoni nudisti –in prevalenza greci- che stazionavano da ormai due mesi sulle spiaggia di Rakuna (una spiaggia poco più in là sull’isola) tra bonghi e canne.
Mi disse inoltre che solo la parte dell’isola su cui ero sbarcato era abitata e “praticabile”. Cioè che la quattro o cinque spiaggie allineate una dopo l’altra su quel lato dell’isola erano collegate da una strada (l’unica insieme a quella che conduceva alla Hora) la quale terminava nei pressi di un piccolo monastero. Li, aggiunse, si trovavano anche i resti di un tempio di Apollo e ciò che rimaneva di un castro veneziano in rovina. Sull’altra parte dell’isola invece niente strade –ci si poteva arrivare solo via mare.
Artemis infine mi racconto la storia del suo fratello diciannovenne che il giorno dopo partiva per il militare. Mi disse che lui come altri giovani dell’isola vivevano in una strana condizione d’incertezza tra l’attaccamento ancestrale all’isola e la fuga verso Atene e il mondo civilizzato. Tornai anche le altre sere in quella simpatica taverna a mangiare pesce e prendere il fresco
La mattina dopo invece andai su alla Hora. La corriera s’inerpicava lenta sui numerosi tornanti, in mezzo al tipico paesaggio cicladico, aspro e brullo, a tratti quasi lunare. Ricordo appena sceso dalla corriera il vento fortissimo - che scoprì dopo non essere affatto un’eccezione lassù, ai 200 metri del villaggio - che spazzava l’ammasso di case bianche dell’abitato. La Hora. Un labirintico intrico di vicoletti tortuosi, nei quali perdersi in mezzo a fili di biancheria stesa al sole cocente, azzurri vasi ricolmi di gerani rossi come melograni, vecchi che riposano all’ombra di un muro crepato, casupole di calce bianca dalle imposte dipinte di blu scurissimo. Una selva di carruggi, passaggi, scalinate per cui s’arrampicano donnine rugose, avvolte nelle loro tipiche lunghe vesti nere, portando pesantissimi sacchi della spesa.
Anafi è questo e quasi nient’altro. Un villaggio di pescatori sperduto nel mare, un’oasi di grecia autentica in mezzo (o meglio ai margini) di un arcipelago che (fatta eccezione per poche isole, forse le sole Folegandros e piccole Cicladi) viene sempre più fagocitato dal turismo di massa. Una piccola comunità di pescatori che cerca tanto disperatamente quanto tranquillamente, con sorniona indifferenza, di rimanere attaccata al suo “verghiano” scoglio. La faccia di un Europa lontana, diversa, recalcitrante alla massificazione, all’ avvilente appiattimento culturale della società occidentale globalizzata.Un’isola ancora incomtaminata, ai margini di tutto, fuori da ogni rotta, sospesa nel suo incanto senza tempo.
Francesco Zurlo




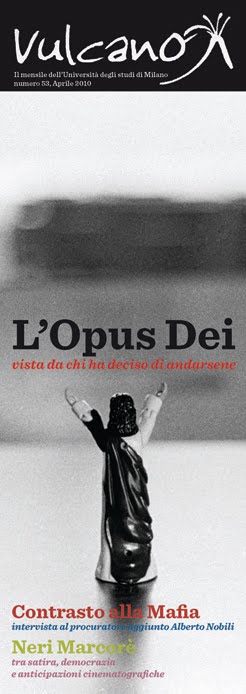















Nessun commento:
Posta un commento