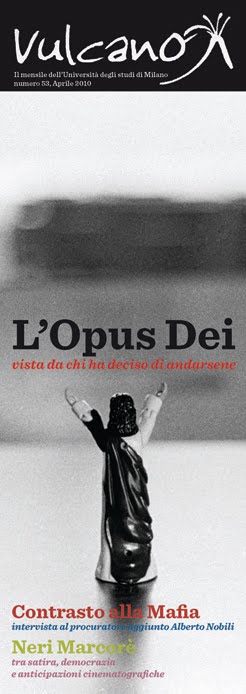Vulcano ha incontrato, presso gli studi milanesi di RockFM, Fabio Treves, storico armonicista e bluesman. Il “Puma di Lambrate” ha inoltre collaborato e suonato con molte rockstar, come Frank Zappa, Eric Clapton, Mike Bloomfield e Stevie Ray Vaughan. Tra dischi curiosi, cimeli e memorabilia, capiamo subito che l’occasione per fare quattro chiacchiere e carpire qualche segreto è davvero troppo ghiotta.
Vulcano ha incontrato, presso gli studi milanesi di RockFM, Fabio Treves, storico armonicista e bluesman. Il “Puma di Lambrate” ha inoltre collaborato e suonato con molte rockstar, come Frank Zappa, Eric Clapton, Mike Bloomfield e Stevie Ray Vaughan. Tra dischi curiosi, cimeli e memorabilia, capiamo subito che l’occasione per fare quattro chiacchiere e carpire qualche segreto è davvero troppo ghiotta.Fabio, potrà sembrarti una domanda ingenua, ma perché hai scelto di fare blues? È pur vero che il contesto musicale dove sei cresciuto ne vedeva la massiccia presenza, ma da cosa ti scaturisce una passione così forte e sincera?
A dirti la verità non so se sia stata una scelta. Penso che per suonare il blues, bisogna sentirlo. Se ascoltando un pezzo di Muddy Waters senti un brivido percorrerti la schiena, o una lacrimuccia solcarti la guancia allora lo senti. È un qualcosa che difficilmente si può imparare, penso sia molto legato ad una sfera istintuale. Per quanto riguarda me, sono cresciuto in una casa dove si è sempre ascoltata dell’ottima musica. Mio padre suonava spessissimo dischi di jazz e qualcosa di blues. Crescendo sono stato folgorato dal rock, come molti ragazzi della mia generazione, ma non ho mai perso la mia passione più grande: quella per la musica del Delta del Mississipi. Gruppi come “The Cream” o “Canned Heat” devono aver fatto da collante facendomi apprezzare anche molti altri generi musicali.
Come hai vissuto gli anni ’70 e il concentrato di eventi musical-culturali di quegli anni?
Li ho vissuti come li può vivere un ragazzo di vent’anni. Al massimo! Ricordo ad esempio di quando andai ad Amsterdam per vedere un concerto dei Pink Floyd, col mio mitico Garelli. Ci misi quattro giorni, ma, una volta arrivato, la soddisfazione fu enorme. In linea di massima, comunque, sono stati anni che mi hanno visto spettatore appassionato e interprete davvero inesperto. Suonavo già in una band di compagni di liceo (il Carducci), e perdevo regolarmente in tutti i concorsi musicali cui mi iscrivevo, perché nemmeno allora il blues era di moda. Nella mia esperienza ha giocato un ruolo davvero importante il festival Pop che si è tenuto nel 1970 presso l’isola di White. Ricordo di essere partito da Milano con una 2Cavalli e che ogni 150 chilometri io e il mio amico Eugenio Finardi, dovevamo fermarci e cambiare l’acqua. Poi, una volta giunti, fu davvero bellissimo. Sentii, tra le altre cose, l’ultimo concerto di Jimi Hendrix, vidi The Who, Santana, Joni Mitchell. Il mio ricordo è quello di un tempo dilatato, un po’ dai tanti anni trascorsi, un po’ dal fatto che l’uso di droghe era piuttosto diffuso. Addirittura, una mattina fummo svegliati da uno strano rumore. Piacevole, dolce. Sembrava il suono di un flauto. Ed era così! Erano gli Jethro Tulls che facevano sound check. Erano così fusi che provavano alle sette del mattino!
Per tornare a te, quand’è che hai capito che potevi fare della musica una professione?
Direi nel 1975. Finito il liceo e accantonata l’università e gli anni dell’impegno politico, capii che suonare era l’unica cosa che mi faceva stare bene per davvero e iniziai ad entrare nel giro. Prima del ’75 (data di fondazione della Treves Blues Band che si esibisce tutt’oggi) avevo provato ad incidere qualcosa, ma il livello era pionieristico.
C’è qualche aneddoto dietro la scelta dell’armonica come tuo strumento preferito?
L’aneddoto più sincero è sicuramente quello della mia propensione ad evitare lo studio di strumenti troppo complessi. Iniziai a suonare il sax, ma facevo molta fatica. Poi vidi l’armonica e capii che era fatta per me. Non aveva bisogno di accordature come la chitarra, né di tecniche particolarmente raffinate, come per il sax. Poi, con la pratica ne misi a fuoco i tanti pregi come, per esempio, il sound, mai scontato.
Senti Fabio, ma a più di 30 anni da quando hai iniziato, che senso dai al fatto che suoni blues?
Come ho già detto, parlando di me, trovo nel blues un valido aiuto contro lo stress, la frustrazione e i ritmi di tutti i giorni. Poi il senso lo da anche il pubblico, giovane e meno, che continua a dimostrarci tantissimo affetto, e a cui va il mio più sentito ringraziamento.
a cura di Davide Zucchi